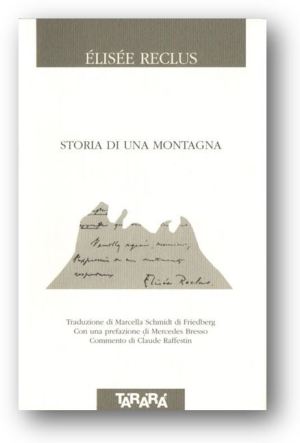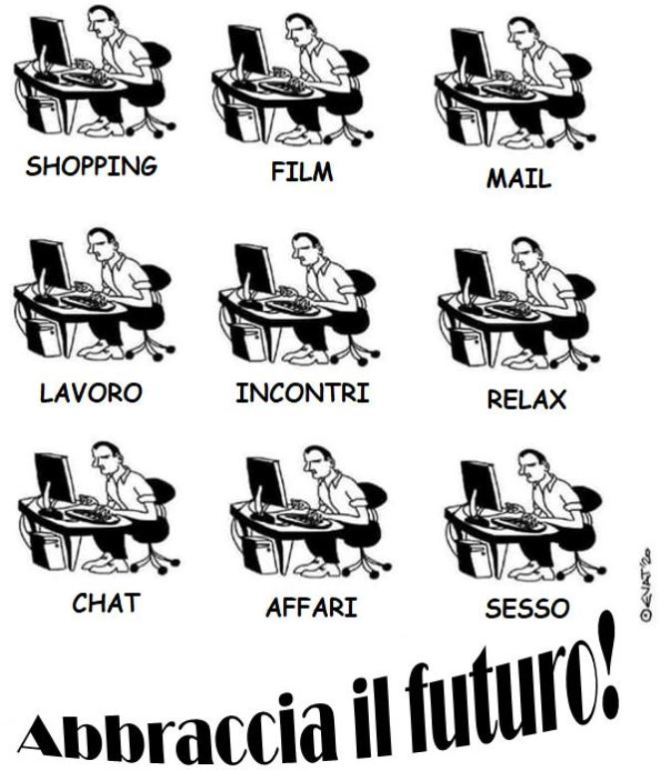Sapete – e, se non lo sapevate, ora sì – che sulla città svizzera di Lucerna, alla quale sono “antropologicamente” molto legato, ho scritto un libro (lo vedete lì sotto, fateci clic) che rimarca, tra le altre cose, la particolare e costante sensibilità personale verso quel luogo e il suo paesaggio peculiare.
Ecco, in un bell’articolo su “SwissInfo.ch” il professor Valentin Groebner, storico austriaco che insegna proprio all’Università di Lucerna, parla della città elvetica, del suo legame con le Alpi e in generale dello sviluppo del paesaggio turistico alpino, rimarcando alcune osservazioni interessanti circa la sua origine, che è sì radicata nel Romanticismo sette-ottocentesco (quello che in pratica ha “inventato” le Alpi in quanto luogo e meta di viaggio) ma non solo nel modo in cui ordinariamente si crede. Ad esempio, Groebner dice che
Nei resoconti di viaggio del XVIII secolo, Lucerna viene descritta come una cittadina triste, antiquata, repressiva e arretrata. Arthur Schopenhauer lo ha espresso in modo sintetico: “Una piccola città deserta e mal costruita. Ma la vista è divina”. Perché questo è ciò che Lucerna aveva da offrire: la vista. Ci sono poche città da cui si può guardare direttamente a sud, attraverso un lago, verso le montagne coperte di neve quasi tutto l’anno. Lo si può fare a Ginevra, lo si può fare a Montreux e proprio qui a Lucerna. E questo lago corrispondeva particolarmente bene allo sguardo romantico sviluppatosi nel XIX secolo.
Questo sguardo è stato importato in Svizzera dai turisti inglesi che hanno visitato il paese dalla fine del XVIII secolo. Uno di loro era il pittore William Turner, il quale ritraendo paesaggi svizzeri primordiali e incontaminati, ha saputo creare per la prima volta sensazioni profonde e romantiche – per i suoi ricchissimi clienti britannici.
In precedenza, la Svizzera era una regione che i viandanti esitavano ad attraversare, a causa delle montagne e del maltempo. Oltretutto gli abitanti usavano lingue strane e incomprensibili. Ma i viaggiatori colti del XIX secolo hanno trasformato il paesaggio della Svizzera centrale in una sorta di compensazione per i danni dell’industrializzazione. L’aria buona e l’acqua pulita erano diventate una merce rara nel resto d’Europa; le Alpi – che si riteneva fossero rimaste “come un tempo” – hanno assunto il ruolo di polo opposto all’Europa industrializzata.
Nel corso del XIX secolo, la Svizzera, i laghi, le montagne sono diventati il luogo dove i fenomeni negativi dell’industrializzazione potevano essere temporaneamente corretti – sempre che ci si potesse permettere di andarci. Birmingham, Manchester e Lucerna sono in qualche modo unite: nelle sporche fabbriche tessili nel nord dell’Inghilterra si guadagna il denaro e i proprietari delle fabbriche lo spendono in Svizzera per riposarsi – in alberghi che sono a loro volta una sorta di fabbriche rosa, costruite in cemento armato come le fabbriche tessili dell’Oberland zurighese e di altri luoghi.
Tali considerazioni (che poi il professor Groebner sviluppa nel corso dell’intervista: leggetela nella sua interezza per coglierne meglio il messaggio) si legano a doppio filo a quanto potete leggere nel mio libro, nelle cui prime pagine non a caso cito quel modo di dire per il quale la Svizzera è considerata “il giardino d’Europa”: ecco, proprio in questo senso lo è, come contraltare naturalmente artificioso, o artificiosamente naturale (la definizione può valere in entrambi i sensi), appositamente concepito per compensare il degrado ambientale e urbanistico verso il quale già nell’Ottocento stavano andando le grandi città industrializzate europee e così preservare la realtà di un territorio, la concezione di un paesaggio nonché il senso di un luogo dall’evoluzione ben più perniciosa del restante continente europeo, proprio come un giardino urbano appare una piacevole oasi di naturalità e di bellezza in mezzo palazzi, strade, piazze e industrie.
Sono considerazioni che peraltro valgono benissimo anche oggi per l’intero territorio alpino, sia quando concepito nella sua interezza, sia quando analizzato nelle varie realtà locali, dove di frequente la stessa particolare relazione tra gli spazi antropizzati e industrializzati e gli spazi mantenuti allo stato naturale e rurale, se non del tutto liberi da segni umani, determina molta parte del senso antropologico e dell’identità culturale di quei territori, determinando di conseguenza anche la relazione delle genti che li abitano ma pure di chi li visita saltuariamente e per breve tempo – in primis il turista, appunto. Una relazione che il professor Groeber delinea in modo ancor più dettagliato nel prosieguo dell’intervista.
 In ogni caso, va da sé che se volete approfondire le riflessioni dell’articolo di “SwissInfo.ch” contestualizzandole al luogo che ne è il soggetto, ovvero alla città di Lucerna – ma, ribadisco, quale luogo emblematico per numerosi altri, nelle Alpi – vi invito a leggere il mio libro e a farmi sapere che ne pensate, oppure – anche meglio senza dubbio! – a visitare Lucerna, una città che sotto ogni punto di vista, materiale e immateriale, non smette mai di sorprendere, innanzi tutto con la sua presenza e l’essenza urbana nel territorio e nel paesaggio nei quali si trova – e, appunto, è una sorpresa tanto grande e costante quanto per nulla meramente e banalmente turistica. Sono certo che, se ci andrete e quale “guida” di viaggio (che non è tale, peraltro, ma forse anche sì!) leggerete il mio libro, mi darete ragione. Già.
In ogni caso, va da sé che se volete approfondire le riflessioni dell’articolo di “SwissInfo.ch” contestualizzandole al luogo che ne è il soggetto, ovvero alla città di Lucerna – ma, ribadisco, quale luogo emblematico per numerosi altri, nelle Alpi – vi invito a leggere il mio libro e a farmi sapere che ne pensate, oppure – anche meglio senza dubbio! – a visitare Lucerna, una città che sotto ogni punto di vista, materiale e immateriale, non smette mai di sorprendere, innanzi tutto con la sua presenza e l’essenza urbana nel territorio e nel paesaggio nei quali si trova – e, appunto, è una sorpresa tanto grande e costante quanto per nulla meramente e banalmente turistica. Sono certo che, se ci andrete e quale “guida” di viaggio (che non è tale, peraltro, ma forse anche sì!) leggerete il mio libro, mi darete ragione. Già.