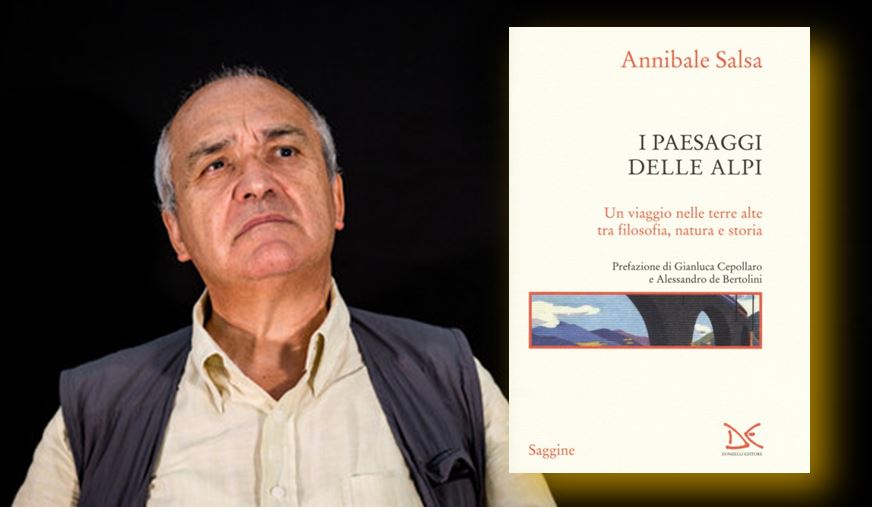È stata una percezione, questa, assolutamente affascinante ma affatto inedita per me. Ho avuto la fortuna fin dalla più giovane età della vicinanza familiare di persone che mi hanno abituato al girovagare consapevole nel paesaggio (soprattutto montano), anche attraverso le più elementari camminate in luoghi apparentemente quotidiani e ovvi, la cui storia geografica mi veniva però raccontata quasi favolisticamente ma, senza dubbio, suggestivamente – almeno per la curiosità d’un bambino che si trova di fronte un mondo intero da scoprire, per il quale un semplice sentiero nel bosco diventa scenografia di infinite bizzarre creazioni della fantasia e stimolo all’esplorazione e alla scoperta di cosa ci possa essere dietro ogni svolta, ogni albero, ogni masso. Uno stimolo spesso ben rifornito di suggestioni proprio grazie alle letture dei libri che, potrei dire, divenivano esercizio per la generazione di un primario, indiretto legame tra narrazione letteraria e narrazione geografica. E se in un punto particolarmente ombroso del bosco non trovavo, io bambino curioso e immaginoso, alcun ingresso d’una casa di gnomi o nessun raduno segreto di elfi poco male: in quei frangenti la curiosità era accesa, l’attenzione resa vigile, e la visione così sollecitata poteva cogliere dettagli altrimenti ignorati e ricavare da essi nozioni più o meno importanti, inevitabilmente ingenue, spesso, ma anche quando minime ed esigue mai insignificanti, mai superflue. Attraverso il moto esuberante seppur disorganico della mia fantasia, stavo imparando a capire che nel paesaggio ogni cosa poteva narrare una storia, tratteggiare una trama, rivelare una verità, magari un segreto – tutto quanto: non solo le creature viventi, anche le piante, le rocce, i più piccoli sassi che tuttavia luccicavano al Sole come (all’apparenza) esotiche pietre preziose… e poi i sentieri, il loro percorso, il fondo, l’ampiezza, i muri, le fontane, gli spiazzi nel bosco, i solchi nel terreno fino all’esiguo panorama visibile tra gli alberi o gli spazi sconfinati dell’orizzonte aperto. Tutto.
Inoltre, grazie a questa costante esplorazione e scoperta leggera e ludica del mondo in cui mi muovevo e fantasticavo, stavo seguendo, a mia insaputa ma con tanta passione, una sorta di corso di estetica del paesaggio, ove la materia più armoniosa era determinata non solo dalla sostanza delle suggestioni ricevute ma pure, se non soprattutto, dalla spontanea, infantile (ma autentica, per gli stessi motivi) percezione del “bello” correlata al ludico, al gioco e al conseguente divertimento, che ogni essere umano in età infantile possiede, e che purtroppo sovente smarrisce nell’età adulta – se non quando ci si ritrova in circostanze ricreative per certi aspetti simili nel principio: non a caso proprio il percorrere un sentiero in ambiente naturale predispone spontaneamente alla percezione sensibile della bellezza di esso e al relativo godimento ricreativo. In tali casi come per me allora, la forma del paesaggio era ed è bella perché osservata senza alcun fine utilitaristico e dunque puramente sollecitante la fantasia: un enorme, vastissimo campo giochi – a prescindere dall’età, a ben vedere – nel quale l’importante non era tanto giocarci effettivamente ma starci dentro. Peraltro, ciò mi fa venire in mente il titolo di una delle più famose opere di letteratura alpinistica dell’Ottocento, The Playground of Europe di Leslie Stephen, filosofo, critico letterario e alpinista tra i più celebri di quel tempo (nonché padre di Virginia Woolf): un libro pubblicato nel 1871 nel qual titolo il vocabolo playground, “terreno di gioco”, non richiama solo al teatro alpino quale ambito d’azione dell’alpinistico pioneristico di quei tempi ma anche (e per certi versi in opposizione a cert’altro alpinismo dall’atteggiamento maggiormente bellicoso e prodromico di quello prestazionale moderno) il senso ludico di tale azione, appunto, per la quale lo stimolo estetico alla conquista delle vette di montagne dalla bellezza meravigliosa, ancorché rude e pericolosa, risultava fondamentale per il successo delle ascensioni e per il godimento intellettuale e spirituale di esse.
Insomma, dicevo: un campo giochi nel quale l’importante è starci dentro e, magari, giocarci. Basta questo, alla fine: il senso del “bello” non abbisogna di molto altro (che è tantissimo, sia chiaro!), solo di poter essere goduto; e solo se goduto, il più possibile liberamente, può essere pienamente percepito con tutte sue forme, segni, scritture, oggettività. La sua comprensione, più o meno intellettuale e altrettanto piena, può semmai venire in un secondo momento, ma senza la percezione di esso, l’intendimento e il riconoscimento, non lo si potrà mai veramente comprendere. Al contrario, conseguendo questa percezione, ne potrà scaturire una comprensione che del valore estetico saprà cogliere tutta l’entità.
Credo sia stato anche da ciò che, già in quella giovane età e poi sempre di più, ho ricavato la mia passione per le carte geografiche: perdermi durante innumerevoli pomeriggi nel vagare in esse con lo sguardo era uno dei passatempi preferiti, cercando di immaginarmi nella maniera più vivida possibile ciò che quelle carte raffiguravano ma, prima, venendo semplicemente affascinato dalla loro grafia, dalla rappresentazione al tratto dell’orografia del territorio e degli elementi antropici, dal seguire le linee che lo percorrevano seguendo direzioni molteplici e a volte inspiegabili e che si intrecciavano, si allontanavano le une dalle altre, correvano parallele, si biforcavano e triforcavano, formavano crocevia o, a volte, finivano apparentemente col perdersi nel nulla. Non lo capivo consciamente, ma dimostravo ciò che le carte geografiche in fondo sono: uno specchio nel quale rifletterci e vederci (o immaginarci) nel territorio, esattamente come ci vediamo nello specchio di casa con attorno la parte di essa nella quale è piazzato. Anche solo in ciò la geografia, e la sua materializzazione più pratica e funzionale, la mappa, dimostra la propria importanza essenziale: per comprenderci nello spazio, dare un senso al nostro moto in esso e per comprendere il legame che ci congiunge al territorio, al paesaggio vissuto e vicendevolmente – tra di noi in quanto creature sociali – ai luoghi in esso. Un legame che ha in sé anche la dimensione del tempo, come sancì già un secolo e mezzo fa il grande geografo francese Élisée Reclus, inventore della “geografia sociale” – base dell’attuale geografia umana – e tra i primi a comprendere come non si potesse elaborare una corretta e completa rappresentazione geografica del mondo senza lo studio storico del moto in esso dei popoli e senza la considerazione degli effetti della loro presenza nei territori attraversati e vissuti, su grande scala tanto quanto in ambiti più piccoli e locali.
Ovviamente a quel tempo, da giovane (e di certo sconclusionato) appassionato di geografia e di lettura delle mappe che ero, non conoscevo Reclus e le sue rivoluzionarie intuizioni. Nel mio piccolissimo, tuttavia, ho continuato nel tempo a mantenere vivo l’interesse per l’esplorazione del territorio e del paesaggio, il che ha reso quella percezione di cui dicevo poco fa sul reale valore dei segni, dei transiti umani e della presenza antropica nel territorio niente affatto una novità: certamente il tempo e l’esperienza l’hanno strutturata, le hanno dato spessore e maggiore riconoscibilità, tuttavia ho dovuto trasformare la percezione in intuizione per dare a quello spessore non solo una forma ma pure una profondità, sì che l’idea finalmente si correlasse tanto allo spazio quanto al tempo – un passaggio “reclusiano” fondamentale, questo, per nulla trascendentale eppure trascurato. Ma, per dire, è come voler andare in bicicletta e trascurare la capacità di stare in equilibrio su due ruote: una capacità che tutti possediamo, peraltro, semplicemente attivandola.