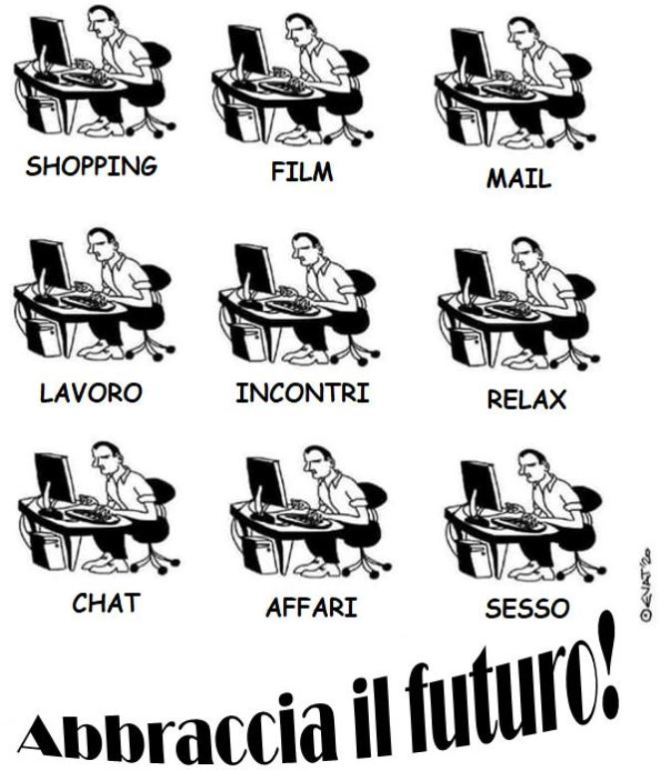[Un’animazione che mostra il cambiamento dei livelli di CO2 in atmosfera durante il lock down per il Coronavirus, dal 1 gennaio al 20 maggio 2020. Fonte: carbonbrief.org]
“Il Post”, in un articolo di sabato 23 maggio 2020 intitolato La pandemia ci ha mostrato una cosa spiacevole sul cambiamento climatico, spiega con dovizia di dati e di particolari ciò che viene poi riassunto dal sottotitolo dell’articolo stesso: «la concentrazione di anidride carbonica nell’aria non è cambiata, nonostante le restrizioni, e c’è un motivo». Il motivo, per farla breve (ma non è spoiler, questo, nel senso: leggetelo l’articolo perché merita molto), è che la diminuzione delle emissioni in atmosfera dovuta al lock down per il coronavirus è durata troppo poco tempo, a fronte di una concentrazione della CO2 in atmosfera che è in corso (e in aumento costante) da decenni e le cui variazioni negli effetti si possono registrare sul lungo periodo, non certo nell’arco di qualche settimana. Ciò significa che, finito il lock down e riprese completamente le attività antropiche come prima della comparsa del coronavirus, ai livelli di CO2 non avremo fatto nemmeno il solletico, per dirla in parole semplici.
Come si denota nell’articolo,
I settori in cui si è visto il maggior calo nella produzione di emissioni di CO2 sono quelli di cui si parla quando si parla di scelte individuali, per diminuire l’impatto delle attività umane sul clima: i trasporti in automobile e i voli aerei. Il fatto che nonostante la loro grande diminuzione, anche nel momento di massime restrizioni mondiali, avvenuto all’inizio di aprile, il mondo abbia continuato a produrre più dell’80 per cento delle sue solite emissioni di anidride carbonica, mostra chiaramente che per contrastare il cambiamento non bisogna chiedere ai singoli di cambiare le proprie abitudini, ma portare avanti cambiamenti più radicali nel modo in cui si produce l’energia.
E, in chiusura,
Zeke Hausfather del Breakthrough Institute, un centro studi americano che si occupa di temi ambientali, ha commentato i risultati dello studio dicendo: «A meno che non arrivino cambiamenti strutturali, dobbiamo aspettarci che le emissioni tornino ai livelli precedenti alla pandemia. Non penso che ci sia un lato positivo della COVID-19 per quanto riguarda il clima, a meno che non sfruttiamo la ripresa delle attività come un’occasione per costruire infrastrutture adatte a sostenere un futuro a energia pulita, oltre che come un momento per stimolare l’economia».
Ecco.
Siccome – lo ribadisco – da quando è iniziata l’emergenza coronavirus continuiamo a dire a destra e a manca che «tutto cambierà» e «niente sarà come prima» ma nulla facciamo affinché queste non sia le solite, ennesime parole al vento, probabilmente per lo stesso principio ci dimenticheremo (pur dicendoci tutti quanti “ecologisti”) che, se prima o poi il COVID-19 verrà debellato, quel virus che da ben più tempo ammorba il nostro pianeta che si chiama “riscaldamento globale” il cui agente patogeno è il genere umano – in particolare la sua parte più supponentemente Sapiens – continuerà il suo decorso e la relativa pandemia fino chissà quali sempre peggiori conseguenze. A meno che, esattamente come accaduto per il coronavirus, la civiltà umana non comprenda finalmente, una volta per tutte, di dover agire con uguale risolutezza e impegno per contenere e infine debellare il “virus climatico”, ad esempio con un bel “distanziamento culturale” globale da quel sistema tecnologico, economico e industriale che ha per gran parte generato tale grave situazione, e un consequenziale efficace vaccino composto da un mix di nuove energie, rinnovati stili di vita e differenti visioni politiche glocal, cioè sia planetarie che negli ambiti locali, fino alla primaria sfera individuale. Perché, come viene evidenziato anche nell’articolo de “Il Post”, non basta cambiare i nostri comportamenti se a ciò non si affianca l’impegno di ognuno per chiedere ai reggenti del mondo di cambiare i loro. Questo, senza dubbio, sarebbe un ottimo e proficuo modo di realizzare concretamente il tanto blaterato «niente sarà come prima».
Altrimenti, la capacità di sopravvivere al COVID-19 prima o poi l’avremo, ma della ben più grande e grave minaccia ambientale e climatica resteremo ancora e più di prima in balìa. Vogliamo che niente sarà come prima o che niente sarà mai più?
Ecco, appunto.