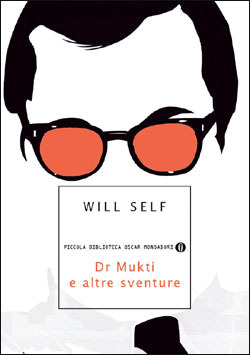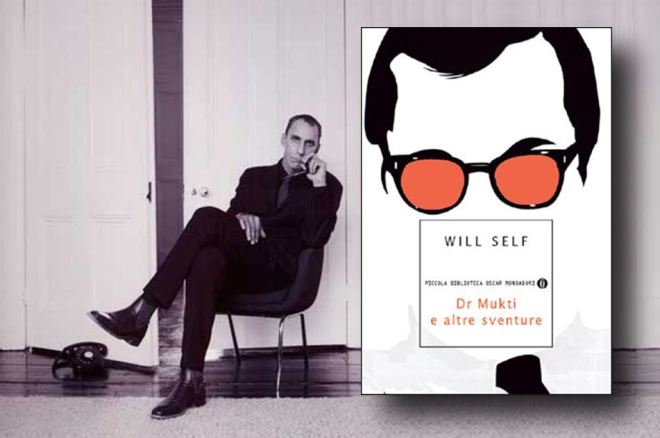Sulla mia carta fai-da-te non sono annotati stati-nazione, ma antiche regioni frontaliere inghiottite dalla geopolitica. Sentite che nomi. “Botnia”, dove il fondo del Baltico muore nella tundra. “Carelia”, un labirinto di fiumi tra Russia e Finlandia. “Livonia”, coperta di laghi e abeti. Ascoltate come suona bene la parola “Curlandia”, terra di lagune e dune di sabbia battute dal vento. Cercate sull’atlante la Prussia Orientale, la Latgallia e la Masuria, vengono i brividi solo a nominarle. E che mi dite della Polesia, lo spartiacque più piatto del mondo, terra dalle cui paludi un tempo potevi scendere in barca sia sul Baltico, sia sul Mar Nero? O delle sterminate colline della Volinia?
E ancora la Rutenia, la Podolia, la Bucovina: provate a fare questi nomi in un’agenzia di viaggi. Vi prenderanno per matti. Ma voi insistete, mostrate la carta geografica, dite che sono posti reali, che contengono fiumi, città, monasteri, sinagoghe, pianure e montagne. Dite che volete vedere anche la Budjak, ultima propaggine dell’Ucraina prima del Delta del Danubio, selvaggia terra di minareti in mezzo a un mare ortodosso, spazio franco di zingari e pastori. Pretendete di visitare la Bessarabia, la Dobrugia e la Tracia. Rieducate l’industria del turismo, spiegate che col petrolio alle stelle il viaggio deve ridiventare avventura e scoperta, mollare i centri rinomati, scegliere le periferie, ridiventare leggeri. In seimila chilometri non ho incontrato un viaggio di gruppo e nemmeno un ristorante cinese. Di italiani meno che meno. Vorrà pur dire qualcosa.
(Paolo Rumiz, Trans Europa Express, Feltrinelli, Milano, 2011, pagg.15-16.)
Questo è, a mio parere, uno dei passaggi più belli ed evocativi del noto libro-diario di viaggio di Rumiz lungo il “confine verticale” europeo, dal Circolo Polare Artico fino al Mar Nero, e ciò per due motivi.
Il primo, perché Rumiz evidenzia nuovamente l’importanza fondamentale dei toponimi, i nomi dei luoghi, veri e propri scrigni lessicali di storie e culture millenarie nonché di relativi saperi, nozioni, rivelazioni sul luogo che denominano nel corso del tempo e sulle genti che lo hanno vissuto, trasformato e abitato. Lo stesso Rumiz in un altro suo bel libro, La leggenda dei monti naviganti, scrive che «Finché ci saranno i nomi, pensai, ci saranno i luoghi» ed è verissimo, perché in effetti è anche grazie al nome che gli uomini gli conferiscono che uno spazio, un territorio, una zona diventa luogo e prende a vivere, a diventare dimora di un proprio Genius Loci. Per questo, in fondo, conoscere e indagare l’origine e il significato dei toponimi significa da un lato viaggiare nello spazio-tempo e, dall’altro, contribuire a mantenere vivo il luogo relativo. Tanta roba da un semplice nome, no?
Il secondo motivo è che in quel brano Rumiz ci ricorda di come molto poco, a ben vedere, conosciamo il mondo che abitiamo, e non territori lontani, esotici e di ostica visita ma regioni che sono parte del nostro stesso continente, in certi casi a un paio d’ore d’aereo o a poche di più d’auto da noi. Eppure la storia della parte di mondo in cui viviamo è ancora in gran parte dentro quei nomi: quelli che sono venuti dopo, sovente per imposizione geopolitica del tutto slegata dalla realtà storico-geografica relativa, sanno raccontare molto meno dei primi delle loro terre, dei loro luoghi, delle genti che vi sono nate o che le hanno abitate, delle loro geografie, morfologie, paesaggi, mitologie. Anche in tal caso conoscerli, quei nomi, e sapere a quali luoghi si riferiscono, non è un mero esercizio nozionistico ma un prezioso esercizio culturale e identitario – di identità virtuosa e benefica, intendo dire, quella che scaturisce da un luogo vivo e per questo identificante, appunto, giammai da una pretesa più o meno localistica che quasi sempre si nutre proprio della carenza di cultura storica, geografica e antropologica nonché di elementi del tutto avulsi e scriteriati.
Ed è un esercizio, quello a cui ho appena accennato, che possiamo fare in ogni territorio e luogo, piccolo o grande, dacché ciascuno di essi ha i suoi toponimi referenziali, identitari, storici, tradizionali, vernacolari, che il passare del tempo e la trasformazione della presenza umana tende a dimenticare e far svanire quando invece la loro salvaguardia è, ribadisco, una fondamentale manifestazione di vitalità culturale e antropologica. Perderne la conoscenza, di contro, significa perdere la storia, i saperi e l’anima dei luoghi in essi racchiusi: qualcosa che una civiltà già troppo smemorata come la nostra non si può assolutamente permettere.