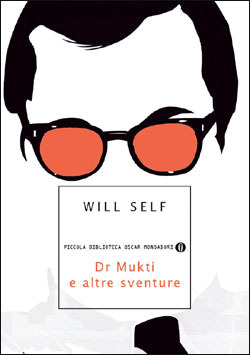Questa mattina, come sempre, scendevo in auto prima delle 7 dalla mia dimora montana verso valle lungo l’abituale strada che per buona parte corre attraverso fitti boschi. D’un tratto sulla sinistra si stacca un sentiero secondario che affonda nel verde arboreo e si dirige verso alcuni edifici rurali. Non so per quale istinto, mentre guidavo, ho guardato nel varco creato dalla traccia nel bosco – non lo faccio quasi mai dacché non ve n’è motivo, quel sentiero non ha granché interesse escursionistico, è solo di servizio alle baite ove porta, fatto sta che ho guardato in quella direzione e sul sentiero, a pochi metri dalla strada e non ancora nascosto dall’ombra boschiva, ho visto un bellissimo capriolo, apparentemente giovane o, forse, una femmina, probabilmente acquattato lì in attesa di non udire più alcuno suono umano per sentirsi sicuro nell’attraversare il tracciato stradale e continuare oltre.
 Una visione simile a quella della foto qui sopra, solo un po’ più da lontano.
Una visione simile a quella della foto qui sopra, solo un po’ più da lontano.
Che in sé, quest’incontro pur fugace non ha avuto niente di speciale, sia chiaro; non è il primo e non sarà certamente l’ultimo. Però, ecco, a viverlo di primo mattino, all’inizio d’una nuova giornata di ordinaria quotidianità, be’, è sicuramente bello e forse più suggestivo che in altri contesti.
Giusto per caso, qualche giorno fa mi sono ritrovato di fronte, in un testo che stavo leggendo, quel celebre passaggio del Canto di Me Stesso, da Foglie d’Erba, nel quale Walt Whitman scrive parole che, mi viene da pensare, sembrano adatte anche a quella mia visione mattutina – e non solo alla circostanza odierna, d’altronde:
Credo che potrei voltare la schiena e andare a vivere con gli animali, così placidi e contenti,
Mi fermo e li contemplo per ore e ore.
Non s’affannano mai, non gemono per la loro condizione,
Non vegliano al buio a piangere i loro peccati,
Non mi danno disgusto discutendo sui loro doveri verso Dio,
Nessuno è insoddisfatto, nessuno impazzisce per smania di possedere,
Nessuno s’inginocchia davanti a un suo simile, né ad altri della sua specie vissuti migliaia di anni fa,
Nessuno è rispettabile o infelice per la terra universa.
Essi mi rivelano i loro rapporti con me e io li accetto,
Mi recano testimonianze di me, e dimostrano chiaramente che le hanno in loro possesso.
Mi chiedo dove mai abbiano raccolto queste testimonianze,
Forse anch’io sono passato da quelle parti, tempi infiniti or sono, e con negligenza le ho lasciate cadere?