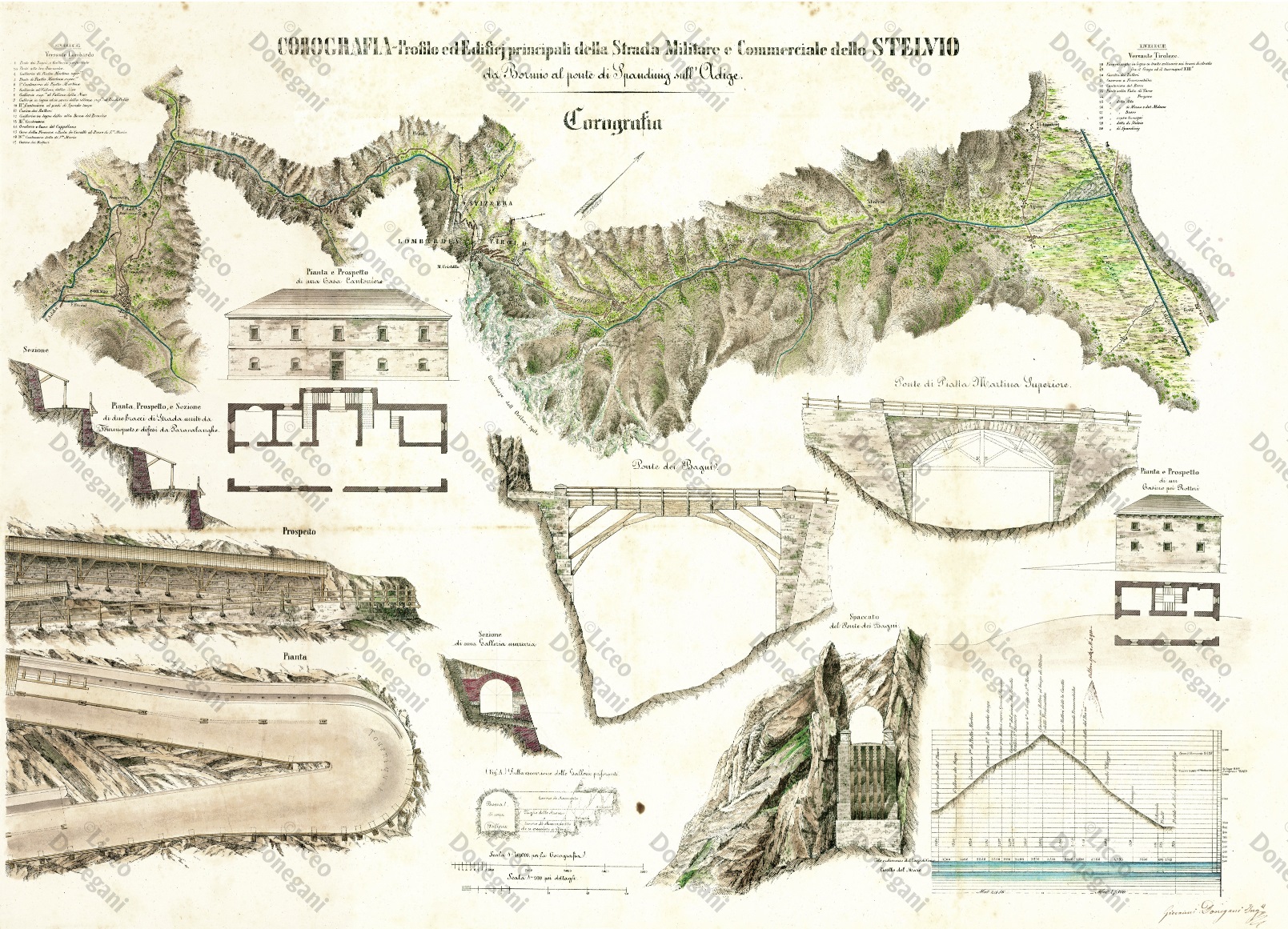Uno degli elementi geografico-geologici più singolari e affascinanti, oltre che premonitori, presenti sulle montagne è sicuramente il rock glacier, o ghiacciaio di pietre, un corpo detritico costituito da pietre a spigoli vivi legate in profondità da permafrost, nell’insieme caratterizzato da forma lobata o a lingua del tutto simile a quella dei ghiacciai, da numerose strutture di flusso sulla superficie nonché da fianchi e fronti molto ripide, e che non di rado conserva al suo fondo (ovvero a profondità di almeno 10 metri) un nucleo di ghiaccio vivo. Una definizione italiana del passato rende bene la particolarità e il fascino di questi corpi, ovvero pietraie semoventi: sì, perché proprio come i ghiacciai queste grandi masse di detriti, se ancora attive, si muovono verso valle a ritmi variabili dal centimetro al metro circa per anno in modi assimilabili a quelli dei ghiacciai.
Uno degli elementi geografico-geologici più singolari e affascinanti, oltre che premonitori, presenti sulle montagne è sicuramente il rock glacier, o ghiacciaio di pietre, un corpo detritico costituito da pietre a spigoli vivi legate in profondità da permafrost, nell’insieme caratterizzato da forma lobata o a lingua del tutto simile a quella dei ghiacciai, da numerose strutture di flusso sulla superficie nonché da fianchi e fronti molto ripide, e che non di rado conserva al suo fondo (ovvero a profondità di almeno 10 metri) un nucleo di ghiaccio vivo. Una definizione italiana del passato rende bene la particolarità e il fascino di questi corpi, ovvero pietraie semoventi: sì, perché proprio come i ghiacciai queste grandi masse di detriti, se ancora attive, si muovono verso valle a ritmi variabili dal centimetro al metro circa per anno in modi assimilabili a quelli dei ghiacciai.
Nelle montagne italiane si contano circa 1.500 rock glaciers sulle Alpi e una trentina sugli Appennini, dei quali circa un quinto attivo e dunque «semovente». Ed è in effetti parecchio emozionante trovarsi al cospetto di queste allungate lingue di pietra sapendo che, impercettibilmente ma incessantemente, da secoli o millenni si stiano muovendo, come enormi e placide creature litiche che conservino al loro interno un cuore di ghiaccio pulsante la propria geologica vitalità, in grado nel tempo di modificare l’aspetto di un territorio e al contempo di preservarne la memoria glaciale.
 Il settore delle Alpi Retiche è particolarmente ricco di rock glaciers – l’alta Valtellina, ad esempio – ma numerosi territori alpini risultano ancora poco esplorati in tal senso. Una zona che personalmente conosco bene, peraltro tra le più interessanti per la sua esposizione a Sud, è quella della Cima di Malvedello, sovrastante la bassa Valtellina e Morbegno. Nella conca chiusa a Nord dall’irregolare costiera del monte ve ne sono diversi di apparati (si veda l’immagine qui sopra), dei quali uno assolutamente significativo: a passarci vicino, sul terreno, non risultano granché evidenti, sembrando più delle ordinarie gande o dei meri corpi franosi (fotografie qui sopra), ma se si sale verso le elevazioni circostanti ovvero ci si fa aiutare dalle immagini satellitari ricavabili sul web, diventano palesi, soprattutto la lunga lingua del rock glacier occidentale che pare proprio un ghiacciaio, nella forma e negli evidenti segni di movimento – i lobi arcuati in successione e le relative fronti, indicati nella mia elaborazione grafica qui sotto – soltanto fatto di pietre, ancorché ormai inattiva (ma forse ancora conservante del ghiaccio al suo interno, chissà).
Il settore delle Alpi Retiche è particolarmente ricco di rock glaciers – l’alta Valtellina, ad esempio – ma numerosi territori alpini risultano ancora poco esplorati in tal senso. Una zona che personalmente conosco bene, peraltro tra le più interessanti per la sua esposizione a Sud, è quella della Cima di Malvedello, sovrastante la bassa Valtellina e Morbegno. Nella conca chiusa a Nord dall’irregolare costiera del monte ve ne sono diversi di apparati (si veda l’immagine qui sopra), dei quali uno assolutamente significativo: a passarci vicino, sul terreno, non risultano granché evidenti, sembrando più delle ordinarie gande o dei meri corpi franosi (fotografie qui sopra), ma se si sale verso le elevazioni circostanti ovvero ci si fa aiutare dalle immagini satellitari ricavabili sul web, diventano palesi, soprattutto la lunga lingua del rock glacier occidentale che pare proprio un ghiacciaio, nella forma e negli evidenti segni di movimento – i lobi arcuati in successione e le relative fronti, indicati nella mia elaborazione grafica qui sotto – soltanto fatto di pietre, ancorché ormai inattiva (ma forse ancora conservante del ghiaccio al suo interno, chissà).



Ecco: i rock glaciers non sono soltanto elementi interessanti e affascinanti dal punto di vista geomorfologico ma, materialmente, ci stanno mostrando oggi come potrebbero diventare le nostre montagne domani, una volta che la maggior parte dei ghiacciai si sarà estinta in forza dei cambiamenti climatici in corso – ecco perché all’inizio di questo testo ho scritto che sono anche elementi “premonitori”. Nonostante la loro origine sia legata alle caratteristiche climatiche degli ambienti periglaciali, dunque freddi, la trasformazione che stanno subendo i territori alpini oltre una certa quota, con le variazioni del clima e la deglaciazione in corso sta probabilmente creando le condizioni per la metamorfosi delle zone ex glaciali in aree ospitanti rock glaciers. Dunque, l’aspetto che presenta oggi un territorio come quello sottostante la citata Cima del Malvedello e il paesaggio che ne possiamo elaborare, facilmente rappresentano il futuro – visivo, estetico, geografico, culturale, eccetera – di numerose altre aree montane in quota con il quale le prossime generazioni dovranno convivere e creare una nuova (ovvero diversa da quella odierna) relazione antropologica.
Per saperne di più, sulle affascinanti ed emblematiche «pietraie semoventi», oltre alle nozioni principali che trovate sulle solite enciclopedie on line potete consultare questi documenti: Pompeo Casati, I ghiacciai di pietre (rock glaciers), e Mauro Guglielmin, Rock glaciers ed altre forme periglaciali. Oltre che, naturalmente, andare a scoprirli e vederli in loco, nel loro così particolare ambiente montano.
P.S.: le immagini fotografiche presenti nell’articolo sono ricavate dal sempre interessante sito web “Paesi di Valtellina”, curato da Massimo Dei Cas. Cliccateci sopra per visitare la fonte originale.