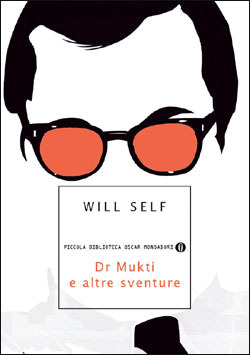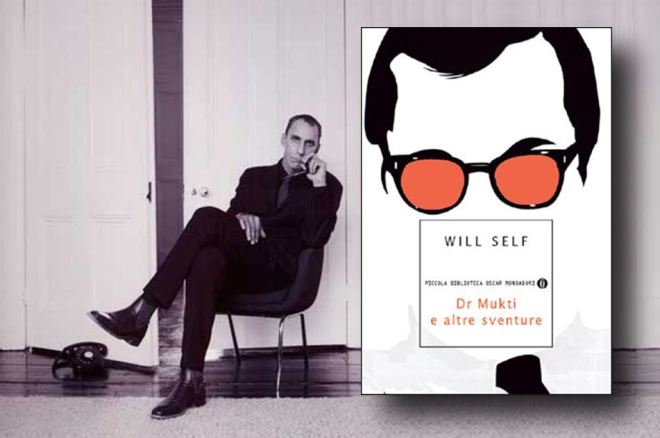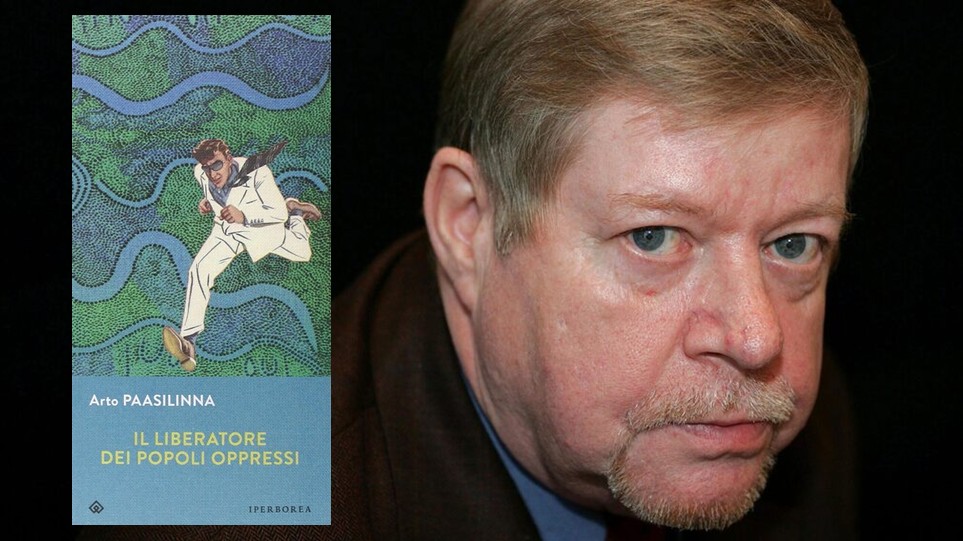Nell’edicola della piazza della Passione vende le riviste, sostituendo temporaneamente il giornalaio, che si è allontanato, una baba analfabeta!
Lo giuro: analfabeta!
Io stesso mi sono avvicinato all’edicola, ho chiesto la rivista «Rossija» e lei mi ha dato «Korabl’» (i caratteri di stampa sono simili). Non va bene. La baba nella sua edicola si dà da fare. Mi dà un’altra rivista. Neppure questa.
«Siete analfabeta?» le chiedo ironicamente.
Ma basta con l’ironia. Viva la disperazione!
La baba era effettivamente analfabeta.
 Ecco, a proposito di Russia odierna, mi viene da dire che quello che racconta qui Michail Bulgakov in Mosca, la Capitale nel block notes (Excelsior 1881, 2007, il passaggio qui citato è alle pagg.64-65) è un po’ quello che sta accadendo alla Russia in generale nelle mani di Putin: un paese grande, forte, colto, emblematico, reso per così dire “analfabeta” in quanto al suo status di comunità politica, così che in antitesi alla storia contemporanea – e non solo al popolo russo – che richiede autentico progresso, evoluzione sociale, sviluppo culturale, il potere oligarchico putinista spinge il paese all’indietro, verso tempi geopoliticamente oscuri, anacronisticamente assolutistici e assai pericolosi per la Russia rispetto al resto del mondo avanzato. Che non è il “paradiso”, sia chiaro, ma nemmeno un posto ove la repressione violenta del dissenso è divenuta ormai la palese (e vile) strategia primaria di salvaguardia del potere, purtroppo.
Ecco, a proposito di Russia odierna, mi viene da dire che quello che racconta qui Michail Bulgakov in Mosca, la Capitale nel block notes (Excelsior 1881, 2007, il passaggio qui citato è alle pagg.64-65) è un po’ quello che sta accadendo alla Russia in generale nelle mani di Putin: un paese grande, forte, colto, emblematico, reso per così dire “analfabeta” in quanto al suo status di comunità politica, così che in antitesi alla storia contemporanea – e non solo al popolo russo – che richiede autentico progresso, evoluzione sociale, sviluppo culturale, il potere oligarchico putinista spinge il paese all’indietro, verso tempi geopoliticamente oscuri, anacronisticamente assolutistici e assai pericolosi per la Russia rispetto al resto del mondo avanzato. Che non è il “paradiso”, sia chiaro, ma nemmeno un posto ove la repressione violenta del dissenso è divenuta ormai la palese (e vile) strategia primaria di salvaguardia del potere, purtroppo.
N.B.: per la cronaca, nelle lingue slave il termine baba significa “donna anziana”, “vecchia”, “nonna”, con accezione affettuosa anche se non di rado in tal senso sarcastica, cfr. Baba Jaga, vecchia strega malvagia – ma in modo ambiguo – delle fiabe slave e in particolar modo russe.