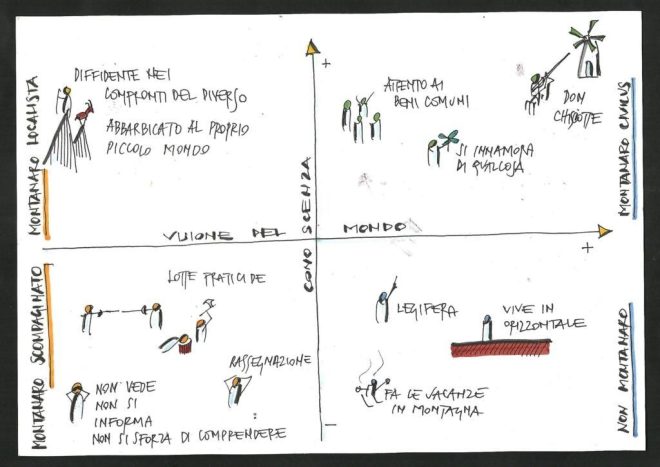L’immagine lì sopra, mirabilmente realizzata dall’amico Marco Lanzavecchia (che ringrazio di cuore per avermela concessa) nella quale è visibile un meraviglioso scorcio del territorio in prossimità dei Piani di Castelluccio di Norcia prospiciente il Monte Vettore (la sommità più alta visibile nella foto è la Cima del Redentore, 2.448 m, una delle vette del monte) trovo che sia assolutamente significativa riguardo ciò che voglio dire. Non ci sono punte e torri acuminate, grandi pareti o creste vertiginose come sulle Alpi, ma la morfologia assolutamente particolare, l’ariosità della visione, la grandiosità della geografia e dunque la potenza pienamente alpestre che si coglie da una tale visione rappresentano delle peculiarità non soltanto spettacolari alla percezione e emozionanti alla considerazione, ma pure in grado di identificare un paesaggio di bellezza e valore culturale rari, con il quale l’instaurare una relazione da parte di chi lo visita e lo vive è una pratica necessaria tanto quanto naturale, come se questi luoghi potessero risultare per vari motivi oltre modo accoglienti, e non solo per il corpo e la mente ma pure per l’animo e lo spirito.
In veste invernale, poi, con la neve al suolo e cielo sereno (non solo in tali condizioni, ma certo con esse in modo più evidente) la luce che emanano luoghi e paesaggi così aperti, intensi e profondi è a dir poco speciale, forse unica, come in effetti la definì Vincenzo Cardarelli in Sera di Gavinana:
Ma come più rifulge, nell’ora che non ha un’altra luce, il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino.
Anche per questo, le geografie dei luoghi degli Appennini si fanno facilmente geografie dell’anima, e paesaggi interiori capaci di suscitare sensazioni di grande armoniosità per certi versi più di quanto sappiano fare le Alpi, a volte troppo morfologicamente rudi e dunque formalmente meno accoglienti. Viene più semplice relazionarsi, con queste montagne, ma d’altro canto viene anche più spontaneo perdersi in esse – consapevolmente, intendo dire – per lasciare che la scoperta e l’emozione conseguente crescano e s’amplino passo dopo paso senza che vi siano sommità troppo “marcanti”, troppo georeferenziali che potrebbero riservare soprattutto ad esse l’attenzione del viandante distraendolo da altri luoghi meritevoli. Ma le montagne d’Appennino sono comunque grandi, in un ordine dimensionale che contempla meno la mera altitudine e più la vastità e la complessità delle proprie orografie, con ciò donando la sensazione di una potenza alpestre, come scrivevo poco sopra, assolutamente compiuta e affascinante. E in effetti dell’intrico morfologico appenninico e di quanto fosse intrigante se n’era già accorto Goethe a inizio Ottocento, il quale annotò le sue impressioni al riguardo nel celeberrimo Viaggio in Italia:
Gli Appennini sono per me un pezzo meraviglioso del creato. Alla grande pianura della regione padana segue una catena di monti che si eleva dal basso, per chiudere verso sud il continente fra i due mari. Se la struttura di questi monti non fosse troppo scoscesa, troppo elevata sul livello del mare e così stranamente intricata; se avesse potuto permettere al flusso e riflusso di esercitare in epoche remote la loro azione più a lungo, di formare delle pianure più vaste e quindi inondarle, questa sarebbe stata una delle contrade più amene nel più splendido clima.
Viva gli Appennini, insomma, montagne eccezionali che mi auguro di poter esplorare e conoscere negli anni prossimi ben più di quanto abbia fatto finora.