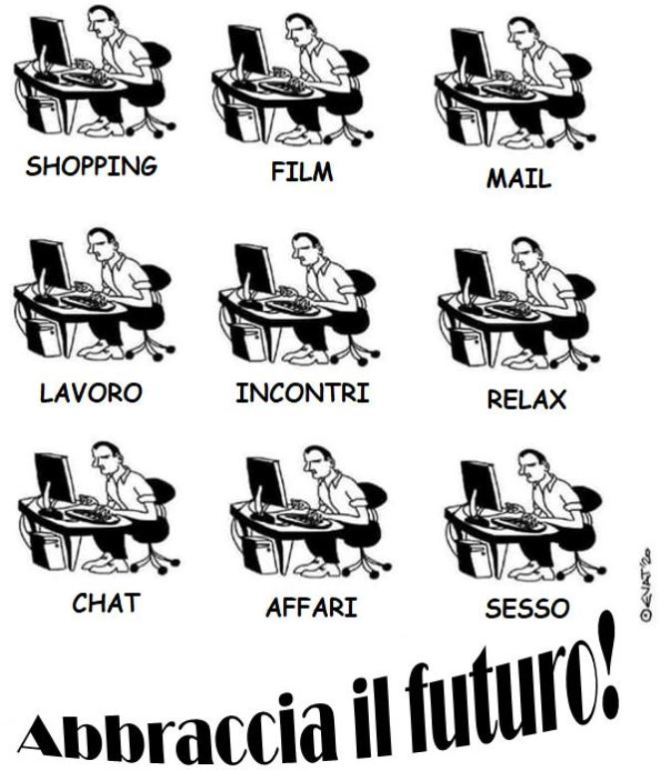Ecco, comincio proprio dalla definizione “scientifica”, quella più o meno univocamente rintracciabile sui dizionari (qui, ad esempio):
wilderness (/’wildernes/ wil|der|ness, 1995; ingl. wilderness /’wɪldənɪs/, der. di wild, “selvaggio”): la natura allo stato selvaggio, non alterata dall’intervento dell’uomo, spec. con riferimento a un ambiente indispensabile alla conservazione delle biodiversità.
Inoltre, tolgo subito dal tavolo sul quale metterò le “carte” da analizzare qualsiasi riferimento alla “wilderness” che si può trovare con inopinata frequenza su materiali di promozione turistica, con relativa pseudo-accezione commerciale: ad esempio ne ricordo alcuni, particolarmente ridicoli, che parlavano di escursioni nella “wilderness” presso alcune rinomate località sulle Dolomiti, a poche centinaia di metri da piste da sci, funivie, rifugi, strade, parcheggi… insomma, una roba veramente grottesca. Ecco, questa brandizzazione del termine “wilderness” che, travisandone totalmente la definizione, ne trasforma l’essenza in un prodotto commerciale farlocco da vendere a quei turisti i quali, abituati al caos della vita contemporanea, potrebbero credere di essere nella “wilderness” anche tra gli alberi di un parco pubblico in centro a Milano (con tutto il rispetto, sia chiaro), fate conto che non esista nemmeno, quantunque non sia un’invenzione totalmente contemporanea ma sia figlia dell’immaginario collettivo alpino artificiosamente creato con la nascita del turismo moderno, con radici nella visione romantica generata con i Grand Tour ottocenteschi. Anzi, quando vedete che ve la stanno offrendo su qualche brochure promozionale o sito web turistico, quella “wilderness”, statene lontani il più possibile.
Bene, posta quella definizione e la conseguente puntualizzazione, credo sia indispensabile porsi una domanda, prima di proseguire con la riflessione sul tema: bisogna considerare la wilderness attraverso il punto di vista umano, dunque con una visione più o meno antropocentrica, oppure no?
Se dobbiamo considerarci per ciò che siamo, ovvero una specie vivente che come le altre è parte della biodiversità terrestre, verrebbe da rispondere che il punto di vista antropocentrico è ineluttabile. Tuttavia, in questo caso, cioè nell’ottica di «una natura non alterata dall’intervento dell’uomo», potremmo già concludere la riflessione e dichiarare che la wilderness non esiste (più) – e il comparativo “più” con le parentesi è necessario a rimarcare che, al giorno d’oggi, uno spazio naturale non alterato da interventi antropici, materiali e immateriali, non esiste probabilmente più, sul pianeta. Ogni territorio ha ormai subito una qualche sorta di intervento umano, anche se spesso non visibile, senza contare che non di rado quell’intervento, ovvero l’influenza della presenza antropica e della relativa attività modificatrice dell’originario stato selvaggio delle zone naturali, avviene a distanza: basti pensare agli effetti dell’inquinamento atmosferico ma persino, a ben vedere, alla zona più remota, disabitata e selvaggia del pianeta nel mentre che venga sorvolata da un aereo – segno evidente, tecnologico e impattante anche se fugacemente temporaneo, della presenza umana: in quel momento sarebbe ancora in regime di “wilderness”, quella zona? A mio modo di vedere no – e a breve vi dirò anche perché lo pensi.
Prima però consideriamo un’altra definizione di “wilderness”, assolutamente significativa anche in senso politico, quella formulata dal grande ecologo americano Aldo Leopold che nel 1921 la descrisse come «un ininterrotto pezzo di terra preservato nel suo stato naturale, aperto ad una caccia ed una pesca legali, abbastanza grande da potervi praticare un viaggio a cavallo di almeno due settimane, e mantenuto privo di strade, sentieri artefatti, rifugi turistici o altre opere dell’uomo.» Dunque un territorio niente affatto scevro dalla presenza umana, ritenuta anzi necessaria quale attore principale della sua salvaguardia senza mai diventare preponderante rispetto a quella delle altre specie viventi ma sempre armonica (nonostante l’accenno alle pratiche venatorie, che fa ancora oggi discutere anche se nessuno discute l’importanza del personaggio in ottica ecologista): infatti da tale concezione leopoldiana si sono derivate le pratiche contemporanee di difesa e preservazione degli ambienti naturali, delle quali Leopold fu tra i primi promotori e ne viene considerato il padre. Posta questa definizione, si potrebbe tuttavia obiettare che risulta piuttosto in contraddizione con quella scientifica ove si debba considerare che quasi ogni attività antropica, anche quella più virtuosa, manifesti un’evidente predominanza tecnologica rispetto al resto del contesto biologico e, anche per questo, comporti comunque un’alterazione della selvaticità del territorio, operando da una posizione naturalmente disequilibrata rispetto a quella di ogni altra creatura: se attraverso una zona remota priva di infrastrutture umane e, per passare la notte, piazzo una tenda dormendoci dentro, altero la naturalità della zona sia materialmente che immaterialmente – a meno che nel frattempo scoiattoli e volpi abbiano cominciato a produrre a loro volta tende da bivacco in cui rintanarsi! Seppur in senso assoluto, bisogna denotare, anche solo la presenza umana in quella zona ne modifica pur impercettibilmente l’equilibrio naturale, annullandone l’integrità; d’altro canto lo sviluppo tecnologico e intellettuale della razza umana l’ha posta in posizione così lontana e diversa, spesso antitetica, rispetto a tutte le altre razze che il rischio (pericolo) di alterazione dello stato naturale esiste sempre, inevitabilmente, ed è una spetto, questo, che l’uomo dovrebbe costantemente considerare nella sua relazione con gli ambienti coi quali interagisce.
Sia chiaro: questo potrebbe apparire un punto di vista fin troppo radicale, dacché sarebbe da stupidi attraversare qualche zona selvaggia, ad esempio la tundra artica, senza portarsi appresso la tecnologia sviluppata dalla nostra specie solo per restare sullo stesso piano delle altre specie lì viventi e non apparire rispetto ad esse smodatamente avvantaggiati – oltre che alteranti la natura selvaggia di quel territorio, appunto. Cosa vera, senza dubbio; ma se dobbiamo considerare una nozione come quella di “wilderness” nella sua valenza assoluta, che per certi versi è pure assolutista visto come imponga una necessaria radicalità concettuale, e posto come – ribadisco – la nozione venga usata e spesso abusata oltre che distorta verso significati e accezioni che poco o nulla hanno a che vedere con la sua origine, gioco forza si deve pure ragionare in modo il più possibile speculativo ovvero il meno possibile antropocentrico: anche per tale motivo ho posto quella domanda al riguardo, poco fa, circa il punto di vista da adottare per riflettere sulla questione.
Credo dunque sia necessario rimarcare una certa partizione tra il concetto scientifico-biologico e materiale di “wilderness”, quello che fa riferimento alla conservazione delle biodiversità naturali di un dato territorio con tutto quanto a ciò faccia riferimento, esseri umani inclusi (ovvero in riferimento alla loro presenza o alla loro assenza), e un concetto “filosofico” e immateriale che invece punta al valore assoluto della nozione e della sua accezione, il che comporta la necessità di definire anche il senso correlato di wild, “selvaggio”. Cos’è, il selvaggio? Cosa dobbiamo intendere, con questo termine? Una zona inabitabile, ricca di pericoli, priva di risorse che possano garantire la sopravvivenza? Oppure lo è qualsiasi zona sconosciuta, aliena, priva di riferimenti usuali? Oppure ancora lo è ogni territorio nel quale l’uomo non viva stanzialmente, risultando dunque “selvaggio” un attributo di valore lessicalmente contrario a quello di “abitato”?
Come ho affermato poco fa, credo che da qualsiasi punto di vista antropocentrico, anche dal più ecologico, la wilderness non può esistere. Addirittura, mi viene da pensare, in modo tanto speculativo quanto provocatorio, che il concetto “assoluto” di wilderness perde ogni senso e valore nel momento stesso in cui viene pensato, elaborato e strutturato in definizione, perché la sua naturalità originaria viene cancellata ovvero “umanizzata”, seppur solo in modo teorico e immateriale. Per questo ho prima scritto che persino la zona più remota e disabitata, obiettivamente “selvaggia” in ogni senso, cessa di esserlo quando venga sorvolata da un aereo anche se voli a diecimila metri di quota e sulla zona ci stia sopra solo per qualche secondo: basta quel segno pur vago per degradare l’integrità selvaggia, per segnalare la presenza umana e per postulare una possibile alterazione dello stato naturale in loco – anche solo immateriale, ribadisco. D’altro canto, se un territorio in regime di “wilderness” si potrebbe contraddistinguere soprattutto per la sua selvaggia inospitalità, verrebbero da considerare tali numerosi territori iperantropizzati nei quali la presenza umana abbia talmente alterato e rovinato il paesaggio naturale da garantire problemi di sopravvivenza a chi lo attraversi o, peggio, lo viva – penso a certe aree ex sovietiche, ad esempio, disabitate e proprio per questo utilizzate come depositi di materiali altamente inquinanti la cui presenza risulti però invisibile a un eventuale visitatore. Oppure, per concettualizzare ancor più l’esempio: anche un’area antropica apparentemente armoniosa e intatta dal punto di vista ambientale ma nella quale venga piazzato un manufatto totalmente avulso dal contesto, non diventa in tal modo e per ragioni opposte “selvaggia”? Di più: non è “selvaggia” e “inospitale” la zona che ospita uno svincolo stradale in orario di punta? È una “wilderness” uguale e contraria a quella naturale: ma in fondo si usa dire che in numerosi circostanze gli opposti si attraggono (concettualmente) e arrivano a toccarsi, no?
Insomma, per concludere questa mia dissertazione senza tediarvi ulteriormente: è chiaro, come sostiene l’antropologo e geografo Matteo Meschiari, il quale sulla questione ha ragionato spesso e in modi assai brillanti, che il pur ancora giovane concetto di “wilderness” è piuttosto in crisi, oggi, vuoi per una sua inevitabile indeterminatezza (riguardo al contesto odierno), vuoi per quanto sia abusato e travisato, e vuoi perché, come detto, la pervasiva e totalizzante presenza umana sul pianeta, diretta e indiretta, rende l’autentica wilderness (sia nell’accezione biologica che in quella filosofica) qualcosa di estremamente raro nonché, per giunta, svanente nel momento stesso in cui venga “toccata” anche solo fugacemente dall’uomo. Come una bolla di sapone, che vive del suo perfetto tanto quanto fragile equilibrio il quale, finché è mantenuto, le permette di volare qui e là a mezz’aria ma che nel momento in cui la si tocca, anche solo sfiorandola appena appena con la punta di un dito, scoppia e svanisce.
Di sicuro, sarebbe buonissima cosa se noi umani smettessimo di utilizzare il concetto e la definizione di “wilderness” come quasi sempre la utilizziamo, ovvero una sorta di idealizzata altra faccia della medaglia del nostro spesso bieco agire altrove, sul pianeta, un contraltare e un corrispettivo che finisca per (voler) giustificare – anche in forza di un nostro meccanismo inconscio eppur figlio legittimo del progresso umano – il suo opposto, cioè l’esistenza di zone totalmente alterate ambientalmente e biologicamente dall’uomo nelle quali l’equilibrio naturale, e qualsiasi attributo selvaggio, è stato guastato. Di nuovo provocatoriamente (poste le riflessioni che avete letto) dico che, forse, se vogliamo veramente preservare la wilderness di certi territori nei quali la presenza dell’uomo non sia ancora stata troppo alterante, dobbiamo dimenticarci di essa. Cioè dimenticarci di quei territori, cancellarli dalle mappe geografiche e dagli articoli delle enciclopedie, in pratica tornare a qualche secolo fa, quando ancora alcune terre del pianeta non erano state visitate ed esplorate e sulle mappe, in corrispondenza di esse, vi erano degli spazi bianchi privi di alcuna informazione. E pensarli, questi territori, non come spazi “inabitabili” per difficoltà oggettive ma spazi non abitabili per scelte soggettive, perché l’unica concezione di essi sia quella che ne determini la preclusione alla nostra presenza, e ciò senza nemmeno che ci sia bisogno di una qualche norma giuridica o di una decisione istituzionale in questo senso, dacché già solo questa rappresenterebbe una disarmonia, pur immateriale, nei riguardi della loro natura selvaggia originaria.
È possibile qualcosa del genere, secondo voi?
Se sì, allora la wilderness potrà ancora tornare a esistere, da qualche parte sulla Terra. Altrimenti, dovremo probabilmente trasferire il suo concetto su qualche pianeta extrasolare biologicamente vivo del quale prima o poi scopriremo l’esistenza con certezza, ma sul quale dovremo aver cura di non mettere mai piede e nemmeno di inviarci qualche sonda robotizzata. Come su Marte, per dire, la cui wilderness abbiamo già sostanzialmente alterato inviandoci un tot di sonde automatiche, alcune già ridotte a rottami giacenti sulla superficie. Pure lassù, ancor prima che l’uomo ci sia giunto, la wilderness ormai non esiste (più).