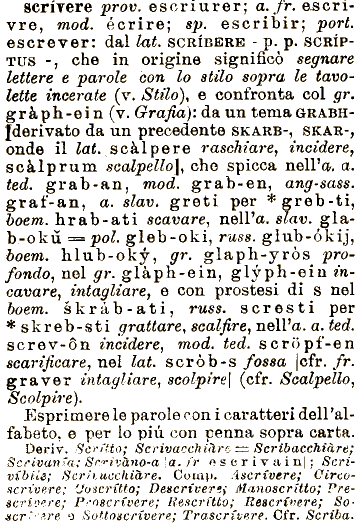P.S. (Pre Scriptum): in queste ore pare che la consegna del Nobel a Bob Dylan da parte dell’Accademia di Svezia stia conoscendo qualche problema… In ogni caso, tenete conto che l’articolo che state per leggere è stato scritto venerdì 14 ottobre, e in fondo i problemi di cui sopra non ne inficiano il senso e la sostanza.
Personalmente, non vedo che cosa ci sia di tanto male nell’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2016 a Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, e dico ciò da grande appassionato di musica e di poesia che non ha mai saputo apprezzare la poetica del cantautore statunitense. Ergo, accetto ma non comprendo tutta ‘sta alzata di scudi da parte degli “scrittori” che, a dirla tutta, mi pare tanto una di quelle difese di parte degli appartenenti ad una casta che vedano minacciato il proprio potere da parte di imprevisti e inopinati “invasori”.
Alessandro Baricco, ad esempio, afferma qui che “Per quanto mi sforzi, non riesco a capire che cosa c’entri con la letteratura”: riflessione comprensibile, di primo acchito, che tuttavia in me viene rapidamente sovrapposta da quella per la quale non capisco cosa c’entrino molti “scrittori” contemporanei, ovvero titolati come tali, con la letteratura. Pensiero che trova una sponda in Alessandro Carrera (apprezzato esegeta dell’opera di Dylan) che su Doppiozero scrive, al proposito: “I vari scrittori, italiani e non, i quali hanno strillato che Dylan non fa parte della letteratura, dovrebbero chiedersi prima di tutto se ne fanno parte loro, perché pubblicare un libro, o anche molti libri, significa essere dei lavoranti della scrittura, il che va bene, ma non significa per forza far parte di ciò che la letteratura decide di essere giorno per giorno.”
D’altro canto già Tullio De Mauro pare aver risposto a modo suo a Baricco, nello stesso articolo, sostenendo che “È giusto allargare i confini del Nobel dalla letteratura accademica, patinata, nobile a quella non meno nobile ma di grande circolazione e popolarità in tutti i sensi della parola.” In verità credo che il Nobel abbia già compiuto più volte, in passato, questa operazione di riconoscimento dell’espressività letteraria (o di natura analoga) “meno nobile” e più popolana – nel senso maggiormente positivo del termine: basta scorrere l’elenco dei vincitori del Premio per rendersene conto, e a ben vedere lo stesso conferimento all’appena defunto Dario Fo è una buona prova di ciò. Per inciso, sarà che mi trovo parecchio affine alla cultura peculiare nordeuropea la cui essenza si ritrova anche nel modus cogitandi delle istituzioni scandinave preposte alla scelta dei vincitori ma, più volte negli ultimi anni, mi sono inizialmente trovato ad avere dubbi su alcuni di essi, salvo poi ricredermi nell’andare a fondo delle giustificazioni alla base dei conferimenti, che ovviamente vanno ben al di là delle tre-parole-tre delle motivazioni ufficiali e che vengono regolarmente pubblicate (e discusse) da molti media in giro per il mondo eccetto che qui in Italia – paese sempre così capace in qualsiasi cosa, invece, a ragionar di pancia per far che il cervello non si usuri troppo sì da (posso ipotizzare) conservare il celeberrimo “genio italico”, con la conseguenza che lo stesso venga inesorabilmente sepolto dalla più polverosa ignavia intellettuale, rendendo invisibile il suddetto “genio”!
In ogni caso, polemismi nostrani a parte: quanto asserito da De Mauro pare anche, indirettamente, fare da contraltare a ciò che invece è dichiarato al proposito da Francesco Giubilei, Editore di Cultora e Direttore Editoriale presso Historica Edizioni e Giubilei Regnani Editore: “L’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan conferma il complesso di inferiorità culturale che vive la letteratura nella nostra epoca, si premia un musicista e non uno scrittore continuando a preferire l’intrattenimento piuttosto che il valore dei libri e della produzione letteraria di un autore. Di questo passo la letteratura è destinata all’estinzione.”
Io invece, per quanto tema l’avverarsi della stessa sorte finale per il mondo dei libri paventata da Giubilei, vedo nel Nobel a Dylan qualcosa di sostanzialmente opposto, ovvero la forza della letteratura capace di inglobare in sé, nel suo grande alveo storico, artistico e culturale, anche espressività apparentemente diverse ma capaci ben più di tante opere classicamente letterarie di comunicare, appunto, qualcosa di ben articolato, determinato e originale a chi ne fruisce. Non penso che la letteratura sia destinata all’estinzione in forza del riconoscimento dell’opera di autori ad essa assimilati di riconosciuta capacità narrativa, per di più certamente di matrice artistica, come Dylan o altri del genere – e non credo ce ne siano tanti in circolazione, dicendolo (ribadisco) da uno che Dylan non lo ascolta e non lo legge dacché preferisce altro; semmai la letteratura li sta covando in sé, o appena accanto a sé, pericoli di estinzione ben più seri, ahinoi, e temo che il panorama letterario italiano sia assolutamente e drammaticamente emblematico in ciò. Ugualmente poi, con De Mauro, non trovo così blasfemo che il Nobel per la Letteratura vada alla ricerca di quelle espressività diverse e/o alternative al tradizionale libro scritto tuttavia tanto capaci di parlare, narrare, raccontare, rappresentare una storia. Credo anche che questa debba essere una prerogativa necessaria della letteratura, peraltro una di quelle che la rende arte nobilissima e insieme accessibile forse più d’ogni altra per come possa elevare a vertici artistici assoluti quanto di più primigenio possieda l’uomo, per costruire la propria identità: il racconto – di sé, della vita, della realtà, di fantasia eccetera.
Per certi versi mi sembra un situazione analoga a quella vissuta nell’ambito artistico visuale dalla fotografia, per lungo tempo denigrata dall’establishment artistico dacché considerata figlia di un dio minore – anzi, peggio, roba da derelitti indegni d’essere accettati nel club degli artisti veri e oggi invece non solo totalmente ammessa ed anzi celebrata con tutti gli onori, ma in certi casi divenuta persino disciplina espressiva di riferimento per buona parte del mondo artistico contemporaneo. Ciò non significa che abbia più valore – culturale, intendo dire – uno scatto fotografico da una tela di Lucio Fontana, semmai significa che anche una fotografia può raggiungere facoltà espressive riconosciute come un’opera d’arte visiva classica. Idem per la questione del Nobel dato a uno strimpellatore di seicorde nemmeno troppo intonato come Dylan.
Questo è quanto, per ciò che mi riguarda. Ben venga il Nobel a Bob Dylan, dunque, ma un ultimo appunto: se tale conferimento “alternativo” del Premio porterà a una oggi inconcepibile, inopinata e degradante devianza dello stesso e dei suoi parametri per la quale, tipo tra venti o venticinque anni, daranno il Nobel a Jovanotti oppure a Ligabue, giuro che dichiarerò guerra alla Svezia e ne farò terra bruciata. Ecco.
P.S.: articolo pubblicato anche su Cultora, qui.
 Ha ragione, Larsson: leggere un buon libro è come affrontare un bel viaggio, e i viaggiatori autentici non sono tanto quelli che visitano i luoghi in cui giungono, semmai quelli che si fanno visitare da quei luoghi. Ugualmente, il lettore autentico è colui che nel libro vi penetra dentro al punto da far che il libro entri dentro lui. Solo in tale condizione la lettura può dirsi compiuta, il lettore definirsi veramente tale e lo scrittore ritenere raggiunto il fine massimo per cui scrivere un libro. Nessuno dei due può uscirne indenne, appunto; entrambi devono venirne fuori cambiati da come erano prima – della scrittura e della lettura. Altrimenti leggere libri diventa un meraviglioso esercizio fine a sé stesso, infinitamente migliore di tante altre attività ma mai totalmente compiuto e dunque potenzialmente sterile.
Ha ragione, Larsson: leggere un buon libro è come affrontare un bel viaggio, e i viaggiatori autentici non sono tanto quelli che visitano i luoghi in cui giungono, semmai quelli che si fanno visitare da quei luoghi. Ugualmente, il lettore autentico è colui che nel libro vi penetra dentro al punto da far che il libro entri dentro lui. Solo in tale condizione la lettura può dirsi compiuta, il lettore definirsi veramente tale e lo scrittore ritenere raggiunto il fine massimo per cui scrivere un libro. Nessuno dei due può uscirne indenne, appunto; entrambi devono venirne fuori cambiati da come erano prima – della scrittura e della lettura. Altrimenti leggere libri diventa un meraviglioso esercizio fine a sé stesso, infinitamente migliore di tante altre attività ma mai totalmente compiuto e dunque potenzialmente sterile.