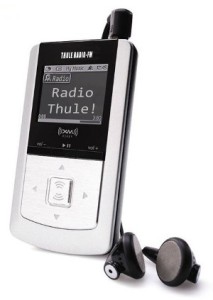L’incontro con la montagna, quando assume il valore di un’esperienza autentica, capace di provocare, in chi la vive, una vera crescita interiore, non può prescindere da due condizioni gemelle: la solitudine e il silenzio.
Solitudine e silenzio non sono corollari marginali, facoltativi, come alcuni stoltamente credono; ma rappresentano i perni indispensabili su cui s’incardina qualsiasi rapporto significativo tra gli esseri umani e i grandi spazi incontaminati della natura.
Gli esseri umani troppo spesso attraversano gli spazi naturali avvolti in una nube di rumore: scafandro sonoro che li rende irrimediabilmente avulsi da quanto li circonda; rozzi astronauti, capitati per caso su un pianeta estraneo e incomprensibile, incapaci di decodificare il messaggio della natura. Quel messaggio eterno che vive e parla attraverso la voce del silenzio.
Se i rumori si aprono la strada violentemente, anche contro la nostra volontà, attraverso l’organo dell’udito, i suoni della natura entrano in noi – e si depositano gentilmente in noi – attraverso tutti i sensi. Impariamo ad ascoltare il silenzio. E ad amarlo, come si ama un insostituibile tesoro.
(Carlo Alberto Pinelli, Riflessioni sul silenzio, 2003, ripubblicato su “AltriSpazi” il 18 gennaio 2025.)
Ciò che scrive Pinelli – figura che nell’ambito della montagna e dell’ambientalismo non ha bisogno di presentazioni – è assolutamente condivisibile, in primis per il fatto che per le montagne e gli ambienti naturali in genere, l’anima dei luoghi e la loro identità culturale, costruita come ogni “identità” anche sull’alterità rispetto agli spazi antropizzati, deve contemplare la solitudine e il silenzio come elementi peculiari e referenziali.
D’altro canto posso capire che qualcuno ritenga le considerazioni espresse da Pinelli troppo radicali rispetto alla realtà delle nostre montagne, le Alpi soprattutto, il cui essere la catena montuosa più antropizzata del mondo (a prescindere da cosa ciò comporti nel bene o nel male) rende l’aspirazione alla solitudine e al silenzio per certi versi un’utopia e per altri versi una dimensione apparentemente contraria alla presenta umana su monti.
Tuttavia, è lo stesso Pinelli a fornire la chiave di lettura forse migliore in assoluto a tale questione, citando i rumori che «si aprono la strada violentemente, anche contro la nostra volontà» oltre che contro la realtà naturale delle montagne. Ecco: il problema non è tanto il rumore antropico in sé, che può ben essere un segno di vitalità umana armonica nel contesto montano nonché un elemento peculiare del suo paesaggio sonoro locale, ma è come viene imposto, con quale scopo, con quale attenzione o quale disinteresse verso il luogo che lo subisce, con quali conseguenze sul luogo stesso e su come lo si può vivere. Conseguenze non solo materiali del momento, ma pure immateriali, ovvero culturali, sul lungo termine, come ad esempio il rischio che l’abitudine al rumore ci faccia disimparare l’ascolto e l’apprezzamento del silenzio.
E quando uno spazio montano produce gli stessi rumori e simili disturbi sonori ovvero assume le stesse caratteristiche ambientali di uno spazio antropizzato e/o urbanizzato, il primo perde ogni suo attributo peculiare. Diventa un non luogo, privo di anima, di propria identità, di uno scopo culturale e antropologico e per ciò verrà vissuto in modo superficiale, incivile, maleducato, altrettanto rumoroso. È l’inizio della sua fine, in pratica.