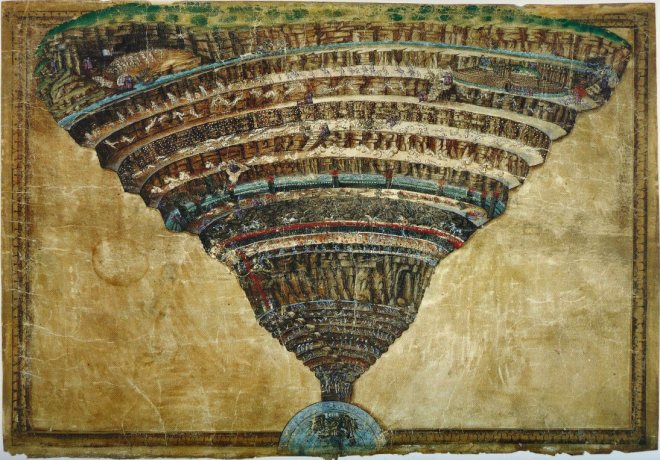Sapete che mi occupo di frequente, qui sul blog, di commistione tra arte visiva e arte letteraria, ovvero tra opere artistiche contemporanea ordinariamente dette e libri (che arte sono, appunto, ma spesso ignoriamo la cosa anche per colpa di chi li scrive).
Sapete che mi occupo di frequente, qui sul blog, di commistione tra arte visiva e arte letteraria, ovvero tra opere artistiche contemporanea ordinariamente dette e libri (che arte sono, appunto, ma spesso ignoriamo la cosa anche per colpa di chi li scrive).
Tuttavia, disquisendo di vari argomenti e, per così dire, osservano la questione dalla parte opposta, è interessante considerare quando non sia l’arte visiva a inglobare in sé il libro – come soggetto, oggetto, concetto o che altro – ma viceversa siano i libri a inglobare l’arte, ovvero a trattarla, a esserne media culturale. In effetti i testi d’arte sono un settore del mondo editoriale e letterario assai articolato e importante, non solo in tema di incidenza sulla produzione libraria, ma sono pure un genere – se si può usare il termine anche in questo caso – ricchissimo di opere fondamentali dal peso culturale notevole nonché di potenzialità letterarie veramente interessanti e non solo riservate, riguardo la lettura e temi trattati, agli appassionati d’arte. Ultimo ma non ultimo, pure i libri d’arte sono parte (scusate la eco onomatopeica!) di quel grande, variegato e tribolato pianeta dell’editoria – di quella nostrana nello specifico, dunque a loro volta e a loro modo indicatori di come stiano andando le cose, sulla sua “superficie” e pure in profondità.
Al recente Forum per l’Arte Contemporanea di Prato si è svolto un illuminante dibattito sul tema, dal titolo “Editoria: circolazione della conoscenza” e a cura di Barbara Meneghel. Ne ha ricavato un report completo Marco Arrigoni per il magazine d’arte contemporanea ATPdiary.com, che vi riproduco di seguito – ringraziando di cuore la redazione del magazine per avermi concesso il consenso alla pubblicazione.
 Editoria: circolazione della conoscenza – #ForumArteContemporanea
Editoria: circolazione della conoscenza – #ForumArteContemporanea
“Io mi chiedo se esista davvero un pubblico interessato alle nostre pubblicazioni”… si parla di editoria al Forum dell’Arte Contemporanea a Prato.
Marco Arrigoni, 27 Settembre 2015
Un altro dei temi ‘caldi’ trattati al Forum dell’Arte Contemporanea di Prato – nella sezione “Comunicazione e rapporto coi media” – è stato introdotto da Barbara Meneghel, critica e curatrice indipendente, che ha coordinato “Editoria: circolazione della conoscenza”. A partecipare sono stati critici, editori, giornalisti, direttori di testate.
Ecco i temi affrontati: circolazione dei testi d’arte; reperibilità di testi stranieri in Italia; presenza di bookshop specializzati; distribuzione dell’editoria italiana all’estero; percezione dei testi italiani all’estero; bookshop di musei e fondazioni in Italia; fiere di editoria specializzate di arte contemporanea; cosa significa lavorare per riviste italiane o per riviste straniere in Italia; rapporto tra prodotto cartaceo e rivista online; grafica; rapporto tra prodotto editoriale e mostra.
Il tutto, chiarisce Barbara, mantenendo ben distinti spazio online e luogo fisico di reperibilità del testo.
Alcuni elementi emersi durante il confronto.
Ingrid Melano, fondatrice e presidente dell’organizzazione no profit The Art Markets
Il mio progetto, The Art Markets, nasce nel 2009 ed è uno spazio dedicato ad esperimenti e a progetti di arte contemporanea, inizialmente solo online, mentre da quest’anno ho aperto un bookshop a Milano. In Italia sicuramente ci sono distributori più grandi e collegati a realtà già ben stabilite. In Europa, poi, ci sono realtà editoriale già molto consolidate, soprattutto a Londra e Parigi. Mi pareva che in Italia, però, mancasse un progetto di questo tipo e noi lo abbiamo creato, sia per pubblicazioni italiane che estere. Tuttavia, servirebbe un sostegno da tutto il sistema editoriale italiano. E’ molto difficile creare una rete sia di bookshop generici che di musei, anche perché ci sono realtà editoriali appoggiate a sistemi più conosciuti, come Mousse.
Elena Bordignon, fondatrice e direttrice editoriale del magazine d’arte contemporanea ATPdiary.com
Trovo eroico chi produce libri in tirature limitatissime. Il vero problema sono le fiere di arte contemporanea in senso stretto. Sono stata invitata – con non poche gratificazioni – a partecipare e diverse fiera d’arte in Italia, luoghi importantissimi per piccoli editori e testate sul nascere. Bisogna però sottolineare che, spesso si rilega l’editoria in fondo alla fiera, o in zone poco battute. Qualcosa sta decisamente cambiando, penso ad esempio alla sezione #ArtissimaLive promossa quest’anno ad Artissima: un’area dedicata esclusivamente alle riviste digitali. (…) Penso che il problema stia nel fatto che nello stesso sistema dell’arte si creano tali meccanismi di ‘esclusione’. Bisognerebbe dunque lavorare su questo aspetto di promozione e sostegno dell’editoria, sia essa legata alla produzione di libro d’arte, catalogo o magazine specializzati. Se un direttore di una fiera ritiene che bisogna potenziare la parte principale (o commerciale) legata alle galleria, questo non toglie che vada a discapito della sezione dedicata all’editoria. Bisogna, a mio parare, sensibilizzare questa figure: direttori di fiere, ma anche direttori di musei e fondazione a dare più ampio spazio agli editori, figure importanti nella circolazione della conoscenza legata all’arte contemporanea.
Giovanna Silva, fondatrice e direttrice editoriale della casa editrice Humboldt
Il problema principale di un editore è quello di farsi conoscere. Io ho aperto la mia casa editrice tre anni fa, riservata ad una narrativa di viaggi. Inizialmente i libri erano distribuiti in diverse librerie generiche. Poi la casa editrice ha cominciato ad interessarsi anche di editoria d’arte, il cui mercato è molto diverso. Noi facciamo un libro con un artista, poi chiediamo in quale bookshop vuole che venga esposto. La realizzazione di molti libri nel mercato dell’arte è pagata, ma alcuni libri che faccio sono a mio carico: è in questa misura che il problema della distribuzione è davvero importante. Bisogna poi considerare che in Italia i bookshop dei musei sono ancora in mano ai grandi gruppi editoriali (Electa, Skirà,…).
Francesco Valtolina, art director della rivista d’arte contemporanea Mousse magazine e della casa editrice Mousse Publishing
Io mi chiedo se esista davvero un pubblico interessato alle nostre pubblicazioni e me lo chiedo in modo autocritico. La maggior parte delle vendite dei titoli di Mousse in Italia sono confinate all’interno della specificità di quel titolo. Quando si dovrebbe parlare di distribuzione vera e propria.
Eleonora Pasqui, editor presso Damiani
Nasciamo con un’attenzione particolare per il ciclo vitale del libro, dall’idea, all’evoluzione, sino alla formazione. Io mi sono imbattuta in realtà davvero disastrose e quindi risulta difficile capire se davvero esiste un bacino d’utenza per i libri Damiani. Spesso non si sa neanche come proporre i nostri libri e questo è un problema enorme. Poi, nel momento in cui ci sono incontri con la catena degli agenti, le persone non ti ascoltano nemmeno. I problemi sono diversi. Dopo 7 anni di disastri, di 50% di resi, essere presenti in migliaia di punti vendita e non essere da nessuna parte, abbiamo cambiato completamente e ci siamo rivolti ad un distributore molto più piccolo, con solo 5 agenti e un numero di punti di vendita molto inferiore, ma i resi sono diminuiti di parecchio. Questo è il mercato italiano, quello estero è completamente diverso: esiste una preparazione degli agenti di vendita completa, reale: vengono da percorsi di studi d’arte, sono appassionati…
Mirko Smerdel, cofondatore di Discipula, collettivo di ricerca e casa editrice indipendente
Il mio è un punto di vista diametralmente opposto al vostro: noi non siamo una casa editrice, ma un gruppo di artisti che usa il libro per diffondere il proprio lavoro. Abbiamo provato a diffonderlo in Inghilterra e ha funzionato; per la nostra situazione sono molto più importanti le fiere, in cui andiamo a dare personalmente i libri a bookshop, come li distribuiamo personalmente in giro per l’Europa. Discipula non è una rivista che si compra perché già si conosce. (…) Facciamo libri che devono essere ogni volta promossi e dove l’aspetto “tattile”, dimensioni, carta, grafica, diventano essenziali. Per noi è come fare una mostra. Il problema della distribuzione esiste, ma è importante far capire che esistiamo, quindi qualsiasi tipo di social può essere utile in questo, però sicuramente l’unico modo per l’editoria indipendente sono le fiere, perché sono oggetti che hanno bisogno di essere conosciuti fisicamente.
Saul Marcadent, curatore, visiting professor e consulente
Mi occupo di esperienze editoriali molto piccole, a bassa tiratura, con contenuti di ricerca. Il valore dell’editoria italiana è molto articolato, è cangiante, cambia velocemente. Nel 2009 non esistevano esperimenti, come nemmeno dei progetti pronti ad accogliere ed ospitare certe realtà. C’era stato un boom del free press… e le cose sono cambiate. Ora c’è una varietà interessante di piccola editoria. Due anni fa sono stato invitato da Jacopo Benassi a curare la rassegna Toner (La Spezia), che aveva creato con Cristiano Guerri. Non è facile. In due anni il pubblico è aumentato, quindi c’è, va coltivato e costruito, ma sicuramente non sono grandi numeri. Mi piace l’idea di creare una situazione tale da far venire a La Spezia anche pochi editori, ma interessati a discutere e a confrontarsi.
Pia Capelli, giornalista per Il Sole 24 Ore
Io non mi relaziono ad un ambito di nicchia, ma più mainstream. Ho individuato degli sfasamenti tra pubblico ed oggetto-libro d’arte. Il primo è che c’è molta più gente che scrive d’arte, che gente che legge d’arte. In tal senso, c’è una notevole differenza tra il mondo anglosassone e quello italiano: c’è un’abitudine diversa alla lettura di libri d’arte. Il problema è l’abitudine alla lettura della saggistica d’arte. In Italia si legge poco, eppure si leggono molti libri sul tè verde, sul cibo… Quindi, si legge poco d’arte contemporanea perché c’è poca abitudine alla stessa. E’ un sistema che andrebbe attivato in maniera diversa. L’arte contemporanea è un soggetto, sono delle storie. Inoltre, l’oggetto del libro d’arte è costoso, deve essere bello e non sempre la saggistica che arriva in Italia è bella. Anche libri importanti finiscono con l’essere tradotti in ritardo e finiscono nel dimenticatoio. La proposta è di creare un’abitudine alla lettura d’arte, che diventi un acquisto raffinato, magari anche costoso. Ma se non ce lo facciamo con le tirature generaliste è ancora più difficile farlo con le tirature limitate.
P.S.: trovate la versione originale dell’articolo su ATPdiary.com qui.
 Come Guy Laramee, sul quale ho già disquisito qui sul blog, anche l’artista piemontese Mario Cordero utilizza i libri per creare paesaggi di montagna. Pagine e copertine, sovente di guide di viaggio, sono scavate e plasmate così da far affiorare sulle superfici lavorate un un’amalgama che simula vette e distese di rocce.
Come Guy Laramee, sul quale ho già disquisito qui sul blog, anche l’artista piemontese Mario Cordero utilizza i libri per creare paesaggi di montagna. Pagine e copertine, sovente di guide di viaggio, sono scavate e plasmate così da far affiorare sulle superfici lavorate un un’amalgama che simula vette e distese di rocce. Le sculture di Mario Cordero saranno esposte al Museo Nazionale della Montagna di Torino dal 12 dicembre al 7 febbraio 2016. Cliccate su entrambe le immagini per saperne di più.
Le sculture di Mario Cordero saranno esposte al Museo Nazionale della Montagna di Torino dal 12 dicembre al 7 febbraio 2016. Cliccate su entrambe le immagini per saperne di più.