Ho impiegato qualche giorno per mettere nero su bianco quanto state per leggere, e non certo perché mi mancassero argomenti al riguardo. In realtà La Parola Selvatica. Il Suono, la “performance” (uso questo termine sapendo tuttavia che possa risultare improprio, sotto certi aspetti) di parole e suoni congegnata da Davide Sapienza e Gabriele Mitelli su testi tratti da La vera storia di Gottardo Archi – l’ultimo libro al momento in cui scrivo di Sapienza – e della quale ho avuto la fortuna di assistere qualche giorno fa a una “prova generale” nella sua forma ormai definitiva, che a breve comincerà a girare per luoghi e pubblici vari, è talmente potente e intensa che abbisogna necessariamente, io credo, di un certo periodo di elaborazione, se non di metabolizzazione (intellettuale e spirituale).
Sono 45 minuti circa nei quali la voce di Sapienza, già di suo assolutamente coinvolgente (è una dote rara, che Davide possiede e maneggia con grande capacità) legge parti della vita narrata di Gottardo Archi ricavandone un parlato ritmico, vibrante, che rapidamente prende la forma d’un suono, armonico, sempre equilibrato ma in moto costante, una sorta di melodia narrante in movimento ininterrotto tra visioni letterarie e percezioni emozionali. Il pubblico le ascolta, inizialmente, poi in vari modi ne viene avviluppato, quindi è come se la voce di Davide cominciasse a fluire direttamente dalla mente degli spettatori assorti nell’ascolto e nelle relative costruzioni dell’immaginazione. Si crea quel legame speciale tra autore, narrazione e lettore (che qui assume le vesti di spettatore) che fa di una storia un’esperienza condivisa nonché, subito dopo, un prezioso elemento di cultura partecipata.
Nel frattempo, però, accade qualcos’altro. Un’altra narrazione, dopo qualche attimo da che Sapienza ha iniziato a raccontare, comincia a fluire in una forma diversa, in principio forse un poco confondente ma, dopo poco, sempre più definitiva, chiara, a sua volta intensa e ugualmente ritmica – anzi, eufonica alla voce di Davide. Non le fa da supporto, non è una sonorizzazione del testo letto o una mera scenografica musicale: è veramente un’altra lettura della vera storia di Gottardo Archi. Solo che Gabriele Mitelli non usa la voce: è un musicista, la sua arte consiste nel far parlare gli strumenti che usa, classici – tromba, sax – e contemporanei – elettronica ed effetti vari – dunque è con la loro voce che, insieme a Davide, racconta di Gottardo Archi e della sua così emblematica vicenda nella Bergamo del XVI secolo. In certi passaggi le due narrazioni restano distinte, quasi indipendenti, come se raccontassero di momenti diversi del testo; in certi altri si accostano, si abbinano, diventano una cosa sola, come se Sapienza cercasse in qualche modo di adattare il proprio tono di voce ai suoni e Gabriele facesse lo stesso con i suoi strumenti, modulando le note e gli effetti entro il solco vocale. In altri momenti ancora gli strumenti di Gabriele sembrano quasi rubare la scena e l’attenzione del pubblico alla voce di Davide, come se rivendicassero la possibilità di una più incisiva forza espressiva e, per così dire, volessero scuotere gli spettatori dalla potenziale malia suadente altrimenti generata dal parlato. La voce – ovvero il testo letto e narrato – resta comunque la guida fondamentale della doppia narrazione, resta lei a determinarne direzione e movimento; tuttavia l’impressione è ormai – nello svilupparsi della “performance” – che senza il suono il suo moto risulterebbe meno determinato. È una spedizione esplorativa a due del testo, due rotte simili ma mai uguali verso un’unica meta, due visioni del paesaggio letterario, due interpretazioni che diventano necessarie l’una all’altra e, infine, entrambe indispensabili al pubblico. Se in principio si potrebbe pensare che La Parola Selvatica. Il Suono potrebbe manifestarsi e “vivere” solo di voce o di suoni, alla fine ci si rende inesorabilmente conto che potrebbe accadere, sì, ma sarebbe come un viaggio percorso con gli occhi socchiusi o con l’udito ostacolato, ovvero compiuto lungo una rotta che non consenta di cogliere tutto quanto vi sia ad essa intorno.
Forse a qualcuno un abbinamento di elementi espressivi così apparentemente diversi eppure tanto vicendevolmente compenetrati, e così diretti lungo la stessa direzione e verso l’identica meta, potrebbe dare l’impressione d’una fusione eccessiva ovvero una con-fusione. Be’, se così dovesse accadere, mi viene da pensare che non sia affatto un difetto, questo. In qualche modo entro tale fusione a tratti così magmatica si può ritrovare quella similare confusione di cui soffrì Gottardo Archi nella sua vita quotidiana al cospetto del paesaggio bergamasco in rapida trasformazione – o stravolgimento, quel suo smarrire il filo del discorso con il Genius Loci cittadino, quel suo affanno nel cercare di trovare quanto prima nuovi elementi georeferenziali sia nel paesaggio cittadino che in quello interiore. Ne La Parola Selvatica. Il Suono questo pericolo non c’è, per lo spettatore: Sapienza e Mitelli gli restano accanto per accompagnarlo nel paesaggio sonoro (di voce e di strumenti) esplorato, tuttavia è come se gli dicessero: guarda che questo cammino non è affatto una passeggiata, ha i suoi elementi di attenzione, di tensione, di inquietudine anche, ma come li ha qualsiasi autentico viaggio – li deve avere, affinché lo spirito del viandante resti sempre vigile e perspicace verso ciò che ha intorno.
Ecco: La Parola Selvatica. Il Suono è un formidabile esperimento artistico di “generazione di perspicacia”, se mi passate la definizione. Perspicacia artistica, intellettuale, emotiva, spirituale. In quanto “sperimentale” potrebbe pure non riuscire, con qualcuno, ma solo ove non vi sia una predisposizione, in fondo del tutto naturale, alla conoscenza della geografia umana, intesa come forma/sostanza del mondo quotidiano d’intorno e come similare o assimilabile forma/sostanza della nostra umanità. Altrimenti, non c’è che da viaggiare sulla voce di Davide Sapienza e sulle note di Gabriele Mitelli, sapendo che ogni cosa ne possa scaturire, sia essa piacevole e ammaliante oppure scuotente e conturbante, sarà qualcosa che resterà custodita nel profondo dell’animo, lì dove stanno le percezioni più importanti e utili al nostro stare bene al mondo.
Se vi capiterà di essere in zona, quando lo saranno anche Sapienza e Mitelli, non perdetevela La Parola Selvatica. Il Suono, veramente. E, magari, leggetevi prima La vera storia di Gottardo Archi: non potrà che farvi penetrare ancora più a fondo nel paesaggio così estrosamente narrato e arricchire parimenti l’esperienza che vivrete.
(Le foto dell’articolo sono di Celestino Felappi, che ringrazio molto per avermele concesse.)







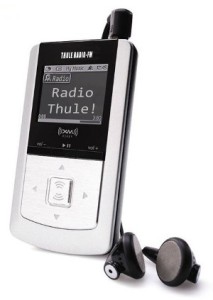
 Chiamatelo film maker, video maker, documentarista o più “tradizionalmente” regista – oppure ancora cineasta, come si diceva una volta… In un modo o nell’altro
Chiamatelo film maker, video maker, documentarista o più “tradizionalmente” regista – oppure ancora cineasta, come si diceva una volta… In un modo o nell’altro 

