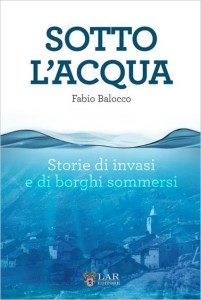Andrea su Facebook mi segnala l’esistenza, da me effettivamente verificata, di un piccolo lago appena sotto la vetta del Ciarforon, una delle sommità più note e prominenti (in forza della sua peculiare morfologia) del massiccio del Gran Paradiso, alta 3642 metri. Il minuscolo bacino è lungo circa 40 metri e largo circa 10, si è formato in una conchetta deglacializzata appena a sud ovest della sommità principale ed è posto a circa 3630 metri di quota:
Toni invece mi ha testimoniato la presenza di un laghetto in prossimità della vetta della Roccia Viva, sempre nel massiccio del Gran Paradiso, dunque a 3650 metri di quota. Tuttavia non trovo tracce di tale bacino sulla cartografia, nemmeno su quella tecnica regionale: potrebbe ben essere che in passato si fosse formato, sempre a causa della fusione glaciale, e poi per motivi geodinamici si sia svuotato.
Ringrazio entrambi per le segnalazioni e tutti gli altri amici che me ne hanno fatte altre di bacini a quote inferiori ma comunque oltre i 3000 metri.
Se alcuni ritenessero questi due specchi d’acqua troppo piccoli e precari per poter essere considerati veri e propri laghi, segnalo che ancora nel gruppo del Gran Paradiso, a oriente della cresta che unisce le vette della Tresenta e della Becca di Montcorvè, nel bacino che ospita il Ghiacciaio di Noaschetta, si è formato e ormai stabilizzato un lago ben più grande, lungo circa 230/240 metri e largo, nel punto maggiore, circa 60 metri, con una circonferenza superiore ai 500 metri, che si trova a 3275 metri di quota, quindi un po’ più alto del Laghetto del Quarnero sul Monviso (posto a 3260 metri) che nel precedente post avevo segnalato come il più elevato al momento rintracciato.



Che è poi un modo – da geonerd, ribadisco, ma tant’è – di rimarcare da un lato la trasformazione a volte significativa (e inquietante, obiettivamente) delle nostre montagne in forza degli effetti della crisi climatica, e dall’altro l’importanza fondamentale delle risorse idriche che le montagne possono darci, a loro volta soggette alle variazioni conseguenti al cambiamento climatico e ambientale in divenire, che inevitabilmente condizioneranno – poco o tanto – la presenza umana in quota, anche quella stanziale, nei prossimi anni.