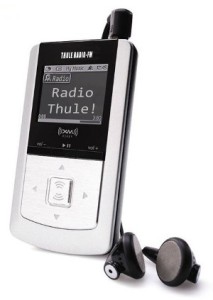(Una rassegna degli articoli più “cliccati” dell’ultimo anno qui sul blog, in attesa di tornare a pieno regime dopo l’agognata e giammai necessaria pausa vacanziera! 😉 )

Un anno fa (questo articolo è stato pubblicato in origine il 10 gennaio 2018 – n.d.L.) ci lasciava Zygmunt Bauman, uno dei maggiori e più influenti pensatori dell’epoca contemporanea, al quale si deve molto della più illuminata visione del tempo presente che possiamo elaborare.
Lo ricorda David Bidussa con un articolo pubblicato sul sito web della Fondazione Feltrinelli, nel quale disserta dell’ultimo lavoro pubblicato da Bauman, Retrotopia, in particolare dell’importanza ontologica della lingua e della fondamentale necessità di denominare le cose del mondo in cui viviamo al fine di identificarle, riconoscerle, condividerne sostanza e senso dunque per porre le migliori basi alla loro comprensione.
Scrive Bidussa al proposito:
Il nome è importante, non solo per i significati che include, ma perché l’atto di denominare non è un dato tecnico, ma descrive un processo culturale e intellettuale di primaria importanza.
È nel nome che la lingua manifesta il suo carattere ontologico: nel nome il mondo viene alla presenza, nel nome l’uomo si apre alla verità del mondo. In esso la parola dell’uomo si apre, prima ancora che alla conoscenza del mondo, all’incontro con il mondo e la sua lingua si svela tutt’altro che semplice strumento per afferrare e impadronirsi di ciò che non ha lingua.
Le cose esistono, ma non basta indicarle. Per comprenderle, perché acquistino per noi un significato, siano discutibili, entrino a pieno titolo nella riflessione pubblica e dunque siano oggetto di confronto, e di crescita, occorre che abbiano un nome. La facoltà di nominare come aveva intuito molto tempo fa Walter Benjamin nel suo Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo (1916), è quella condizione e quella possibilità che consente poi di dare un volto e, nel tempo, contenuto alle cose. Non consente solo di riconoscerle, ma di parlarne.
Non è un caso se tali principi risultino fondamentali anche nello studio geoculturale e antropologico dei territori e dei paesaggi, disciplina che m’appassiona ormai da tempo – altrettanto, non è causale che a mia volta consideri Bauman fondamentale anche per tali studi, attraverso la cui lente mi viene di leggere quanto scritto da Bidussa. Il pensiero del grande sociologo polacco mi fa tornare alla mente quanto ha scritto un altro grande osservatore di mondi, territori, paesaggi, genti e culture, Paolo Rumiz, in La leggenda dei monti naviganti: «Finché ci saranno i nomi, ci saranno i luoghi». È sul serio una verità assoluta, questa: i nomi delle cose, ancor più quando diventano nomi di luoghi dunque toponimi, sono “contenitori” tanto piccoli nella forma quando infiniti nella capienza di culture, sapienze, tradizioni, usi e costumi, storie grandi e belle o tristi e terribili, vicende umane, credenze, leggende, miti. Rappresentano perfettamente il carattere ontologico della lingua citato da Bauman e rimandano allo stesso carattere identitario-culturale del linguaggio, rappresentando pure, i nomi e i toponimi, marcatori referenziali fondamentali alla generazione del legame antropologico tra uomo e territorio, ambiente, paesaggio, spazio (e anche tempo) ovvero con l’intero pianeta sul quale tutti stiamo e con ogni cosa esso contiene. Un legame che, nella sua essenza ancestrale e immutabile, definisce il nostro essere “civiltà” se non, ancor più specificatamente, identifica cosa è la civiltà umana.
Forse Bauman, sostiene Bidussa, ci ha proprio lasciato “orfani” di una parola, un ultimo fondamentale nome, capace di definire una genealogia del presente e identificare, almeno in nuce, il futuro che ci attende. Sicuramente e non solo, dico io: come già scrivevo un anno fa nel giorno della sua scomparsa, un uomo e una mente come Zygmunt Bauman mancheranno sempre di più, alla nostra civiltà e al nostro futuro.
P.S.: potete leggere l’articolo integrale di David Bidussa cliccando sull’immagine in testa a questo post.