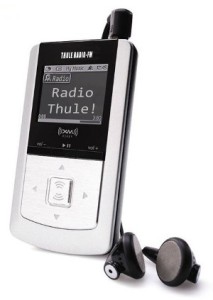Ormai, ogni volta che nel mondo succede qualcosa di spiacevole, sui media si ripete la solita storia: l’uso di parole dal senso e dal valore pesantissimi tanto quanto sostanzialmente travisati o incompresi, con la più ingiustificata e sconcertante leggerezza. Che non serve affatto a descrivere meglio quanto accaduto ovvero ad agevolare la comprensione di quelle parole e dei fatti a cui vengono riferite, tutt’altro: da un lato serve in primis – lo sappiamo tutti bene – per accaparrarsi attenzione superficiale e dunque audience, dall’altro è funzionale a una crescente confusione, a sua volta propedeutica ad un stato di costante paura e insicurezza.
Poco più di un anno fa pubblicavo qui sul blog un articolo dal titolo “Se parole pesanti come macigni divengono leggere come l’aria…”: ecco, ve lo ripropongo, perché la sua validità di senso e sostanza è ad oggi immutata, se non accresciuta. Il che non è affatto un buon segno, per lo stato della società in cui viviamo: ci vengono scagliate addosso parole pesanti come macigni in una sassaiola ormai costante le quali, al posto di fornirci una qualche “nozione” del peso che hanno, finiscono per farci soltanto del gran male.
Buona ri-lettura.

Io farei un libro di pietra che pesa 20 kg perché le parole devono tornare ad avere un peso.
Ha mille ragioni Gian Paolo Serino a sostenere (in un’intervista per la Write and Roll Society) quanto sopra. In effetti trovo parecchio sconcertante come a certe parole parecchio usate e abusate oggi, nel quotidiano contesto politico, sociale e culturale, venga stravolto – spesso totalmente – il peso originario ovvero il senso, il valore il significato fondamentale, per appesantirlo di zavorre tremende come anche per alleggerirlo a furia di escavazioni semantiche. Fenomeno che diventa ancora più evidente quando il presente risulti più turbolento dell’ordinario (o più di quanto non lo fosse già prima, visto come vanno le cose!)
Vi cito qualche esempio – tra i più facili e banali – dei tantissimi che si potrebbero fare sul tema.
La parola crisi è forse la più emblematica di tale processo “contro-semantico” – oltre ad essere forse quella in assoluto maggiormente abusata dai media, dal 2008 a questa parte. Se la sua etimologia originaria rimanda al verbo greco krino, “separare”, “cernere”, in senso più lato discernere, giudicare, valutare, denotando dunque un’accezione positiva, di impulso al cambiamento, al rinnovamento, oggi è stata negativizzata in maniera pressoché parossistica, così che infilarla in un qualsiasi discorso significa macchiarlo di tinte fosche e spedire il suo soggetto verso una fine quasi certamente cupa. Di contro il termine guerra, molto in voga nei giorni in cui scrivo questo articolo, viene da un lato sovraccaricato di paure popolari (o popolane) sovente indotte e usato come attrezzo politico-mediatico parecchio convincente, ma indubbiamente è dall’altro lato scavato di senso autentico e assai superficializzato. Mi viene da pensare che l’uso tanto facile e leggero del termine da parte dei politici contemporanei e dei media è dovuto probabilmente al fatto che buona parte di noi – ovvero tutti quelli che hanno meno di 75 anni – ha avuto la fortuna di non vivere una guerra vera, e di non sapere quindi cosa realmente sia. Motivo peraltro, questo, che in verità giustificherebbe un atteggiamento contrario a quanto invece avviene.
Ci sono poi termini molto “quotidiani” come libertà e democrazia i quali il proprio buon senso autentico lo conserverebbero e pure sostanzialmente intatto, anzi, forse col tempo ancor più determinato, ma che vengono utilizzati con così tanta superficialità e ingenuità, quando non con ipocrisia, da deformarsi e svaporare sempre più nell’intendimento comune. In tal caso è il loro senso a perdere senso, per così dire, ovvero ad acquisire accezioni diverse, credute (e imposte) come conformi a quelle originali e invece del tutto discoste, se non in certi casi antitetiche, sicché l’uso di tali termini risulta il più delle volte francamente fuori luogo. A tal proposito si può denotare che, in questa “categoria” di parole, ve ne sono legate all’ambito religioso che risultano tra le più abusate e distorte, partendo da Dio e finendo a fede – o la stessa parola religione, a ben vedere. D’altronde l’ambito laico ripristina rapidamente la par condicio sul tema: si pensi solo a termini come patria e nazione.
Anche popolo, con le sue varie derivazioni, è un termine di frequente e alternativamente sovraccaricato di significati ovvero sgravato da essi, con ciò assumendo connotazioni sia positive che negative. Bizzarro constatare che, in certi casi, l’accezione positiva serve giustificare un certo vantaggio non al soggetto collettivo stesso identificato dal termine ma ad uno o pochi singoli (“il popolo ha liberamente scelto i propri governanti”) mentre quella negativa a scaricarvi addosso oneri, responsabilità e colpe (“ogni popolo ha i governanti che si merita”.)
A proposito: e politica? Chi si ricorda e considera che la sua etimologia greca originaria – politikḗ (tékhnē), da polis/polítēs, rispettivamente “città” e “cittadino” – ci riporta al significato di “arte di governare la città” ovvero gli stati? Cosa è invece considerata, oggi, se non la mera attività dei partiti “politici” i quali, inutile dirlo, ben poco hanno a che vedere non solo con qualsivoglia arte – e sottolineo arte! – di governo ma pure con il concetto democratico di comunità ovvero del “governo collettivo della cosa comune”? Niente di più lontano oggi, converrete, nella realtà come nel “senso” contemporaneo del termine che la indica.
Potrei continuare ancora a lungo, come detto, ma a prescindere dalla (relativa) ovvietà degli esempi citati, non la faccio più lunga del dovuto e per concludere questa mia dissertazione voglio citare due ultimi sintomatici termini dal senso e dalle accezioni tirate, anzi, storpiate a destra e a manca ad ogni buona (o cattiva) occasione: realtà e verità. Due parole dal significato pressoché “matematico” cioè impossibile da ridursi a mera opinione. Eppure è ciò che (inopinatamente) accade spessissimo, lo avrete notato chissà quante volte, con modalità che la dicono lunga su come funziona (o come non funziona) il nostro mondo contemporaneo nonché, di contro, di come il bisogno di tornare a fissare certi punti fermi fondamentali (come quelli legati alla lingua che parliamo, appunto, dunque alla nostra reciproca possibilità di comunicazione) al fine di non smarrirci dentro quello stesso nostro mondo e nel tempo in cui stiamo vivendo sia sempre più indispensabile. Anzi, ineludibile.
 Anche gli scali aeroportuali milanesi entrano nel prestigioso novero degli “aeroporti bibliofili” e, in occasione di Tempo di Libri, inaugurano le Book Fly Zone: nelle aree arrivi e partenze dei terminal di Milano Linate e Milano Malpensa (terminal 1 e terminal 2) sono state installate ben 9 librerie per il book crossing a disposizione dei viaggiatori in partenza e in transito. Le librerie sono state disegnate da Giorgio Caporaso, creatore della Ecodesign Collection per il brand italiano Lessmore i cui arredi sono espressione di una vera e propria filosofia “green”, rispettosa dell’ambiente e basata sui principi della componibilità, personalizzazione e riciclabilità. Ogni modulo “More Light” delle librerie (45×45 cm) è, infatti, realizzato in cartone 100% riciclabile. L’AIE ha fornito 6.000 libri del progetto #ioleggoperché che, insieme a quelli donati dall’Associazione NoiSeA, rappresentano la dotazione iniziale dei punti di book crossing.
Anche gli scali aeroportuali milanesi entrano nel prestigioso novero degli “aeroporti bibliofili” e, in occasione di Tempo di Libri, inaugurano le Book Fly Zone: nelle aree arrivi e partenze dei terminal di Milano Linate e Milano Malpensa (terminal 1 e terminal 2) sono state installate ben 9 librerie per il book crossing a disposizione dei viaggiatori in partenza e in transito. Le librerie sono state disegnate da Giorgio Caporaso, creatore della Ecodesign Collection per il brand italiano Lessmore i cui arredi sono espressione di una vera e propria filosofia “green”, rispettosa dell’ambiente e basata sui principi della componibilità, personalizzazione e riciclabilità. Ogni modulo “More Light” delle librerie (45×45 cm) è, infatti, realizzato in cartone 100% riciclabile. L’AIE ha fornito 6.000 libri del progetto #ioleggoperché che, insieme a quelli donati dall’Associazione NoiSeA, rappresentano la dotazione iniziale dei punti di book crossing.