 Sovente pubblico qui sul blog dissertazioni – di genere vario ma obiettivo comune – sull’esercizio della scrittura letteraria, lo sa bene chi il blog lo segue con regolarità. Sono profondamente convinto che buona parte dell’attività di scrittura sia fatta dal continuo studio e dalla riflessione del senso, della forma, della sostanza e dell’essenza di essa, e ciò perché scrivere qualcosa che poi venga pubblicato rappresenta una grandissima responsabilità, non solo verso i lettori ma pure verso sé stessi autori. Questo implica che non ci si possa mai sentire “arrivati”, nello scrivere, mai: è come percorrere una strada che può offrire panorami meravigliosi, a volte tranquilla e ampia, altre volte faticosa, piena di ostacoli e della quale non si conosce la fine, ma la cui percorrenza verso quel suo orizzonte indeterminato è fondamentale per non ritrovarsi fermi in mezzo ad essa, statici, privi di moto – qualcosa, dunque, di totalmente avulso dal senso stesso di una strada, che è appunto il viaggio su di essa. E se è vero che, sovente, la meta è proprio il viaggio, direi che ciò può valere anche nella grande avventura della scrittura letteraria, ancor più se nel corso di esso si possono incontrare altri viaggiatori con cui condividere quella strada, quei panorami, le visioni, le sensazioni, le idee.
Sovente pubblico qui sul blog dissertazioni – di genere vario ma obiettivo comune – sull’esercizio della scrittura letteraria, lo sa bene chi il blog lo segue con regolarità. Sono profondamente convinto che buona parte dell’attività di scrittura sia fatta dal continuo studio e dalla riflessione del senso, della forma, della sostanza e dell’essenza di essa, e ciò perché scrivere qualcosa che poi venga pubblicato rappresenta una grandissima responsabilità, non solo verso i lettori ma pure verso sé stessi autori. Questo implica che non ci si possa mai sentire “arrivati”, nello scrivere, mai: è come percorrere una strada che può offrire panorami meravigliosi, a volte tranquilla e ampia, altre volte faticosa, piena di ostacoli e della quale non si conosce la fine, ma la cui percorrenza verso quel suo orizzonte indeterminato è fondamentale per non ritrovarsi fermi in mezzo ad essa, statici, privi di moto – qualcosa, dunque, di totalmente avulso dal senso stesso di una strada, che è appunto il viaggio su di essa. E se è vero che, sovente, la meta è proprio il viaggio, direi che ciò può valere anche nella grande avventura della scrittura letteraria, ancor più se nel corso di esso si possono incontrare altri viaggiatori con cui condividere quella strada, quei panorami, le visioni, le sensazioni, le idee.
Emanuela Ersilia Abbadessa, raffinata e arguta scrittrice (ma non solo – l’ultimo suo libro è questo) è certamente una di essi. A sua volta spesso medita sul senso dell’esercizio della scrittura, riportando poi le riflessioni elaborate in illuminanti articoli, uno dei quali voglio proporvi di seguito. Il tema principale di esso è la responsabilità dell’autore nei confronti della narrazione del “bene” e del “male” e sulla necessaria elaborazione di una consapevolezza circa l’effetto che la forma e la sostanza di questa narrazione può avere sul lettore. Tema assai importante e pesante (di argomenti e di relative possibili elucubrazioni, intendo dire), in senso letterario, ma con il quale prima o poi un autore si potrà ritrovare ad avere a che fare – se scrive autentica letteratura e non storielle da libroidi per ipermercati, certo.
Ringrazio di cuore EE per avermi concesso dal suo convento il consenso alla pubblicazione dell’articolo (che trovate in versione originale qui).
Buona lettura!
 Cara amica,
Cara amica,
qualche tempo fa, mi chiedevi se io scriva tutto ciò che mi passa per la testa e mi trovavo insieme a te a interrogarmi sulle responsabilità di chi usa la parola come mezzo di comunicazione. Naturalmente il gradiente di impegno cambia a seconda dell’uditorio che viene raggiunto e, come sai, credo che scrivere sui social o più in generale sul web, ci carichi di grossi oneri proprio per la vastità del pubblico che ipoteticamente può leggerci. Per questo detesto esprimermi su Facebook, ad esempio, su fatti di forte impatto emozionale o che, come recentemente avvenuto, coinvolgono le esistenze di molti.
 La scrittura di un romanzo offre possibilità di riflessione ancora diverse rispetto a questo argomento. Ho provato a riassumerle in un articolo apparso su “La Civetta” (anno XXI, luglio-settembre-agosto 2016) che ti riporto qui.
La scrittura di un romanzo offre possibilità di riflessione ancora diverse rispetto a questo argomento. Ho provato a riassumerle in un articolo apparso su “La Civetta” (anno XXI, luglio-settembre-agosto 2016) che ti riporto qui.
Devotamente
EE.
Ogni libro è un viaggio. Lo è sia per l’autore che intraprende un cammino scrivendo un incipit, sia per quanti leggeranno. I viaggi ci cambiano e leggere, dunque, è un modo per mettere in mano ad altri la possibilità di cambiarci la vita.
Ogni libro cambia la vita di chi scrive e di chi legge. E facendo scorrere gli occhi tra le righe, anche nell’illusione di tenere tra le mani un qualsiasi mezzo di intrattenimento, una parte di noi è consapevole che le singole parole, il modo di concatenarsi tra loro e i sensi del racconto, alla fine, ci renderanno persone diverse.
Non tutti i libri però danno al lettore la medesima percezione del mutamento. La cosiddetta narrazione di genere, nella rassicurante uniformità di plot che si ripetono sempre simili e nell’osservanza di regole abbastanza precise, appaiono, d’acchito, incapaci di cambiarci davvero. Con i loro buoni e i loro cattivi, sempre caratterizzati da certezze dentro le quali è quasi impossibile fare insediare margini di dubbio, i gialli, ad esempio (così come i romanzi rosa, i noir e tutto ciò che può essere ascritto a una categoria più o meno precisa), rappresentano una realtà talmente fittizia da divenire, per iperbole, rassicurante.
Ma cosa avviene invece quando, fuori dalla narrazione di genere, per dirla manzonianamente, non è possibile dividere il bene e il male con un taglio così netto che una parte dell’uno non resti nell’altro? Accade, che il lettore si trova di fronte a qualcosa in grado di scompaginare le sue convinzioni ma, nello stesso tempo, ha davanti personaggi che somigliano a lui nelle insicurezze, nelle debolezze, nel desiderio di vendetta così come nelle ambizioni, insomma, nel bene e nel male e, a volte, al di là del bene e del male. Cioè, accade che il libro narra effettivamente la vita e non la sua cristallizzazione stereotipata dentro canovacci di genere più o meno aderenti ad essa e che del vero hanno solo la pretesa ma, nei fatti, proprio in forza della divisione netta tra bene e male, consegnano al pubblico un altrove in cui l’ordine interiore rassicura perché diverso dalla vita reale.
Affrontare i grandi temi intorno ai quali l’uomo indaga da sempre – la vita, la morte, l’amore – è compito e responsabilità dello scrittore.
Nel tempo però sono mutati i gradienti di responsabilità e questi temi, non potendo più essere affrontati con i medesimi strumenti, hanno sovraccaricato il narratore di responsabilità, sia al momento dell’indagine, sia in quello della consegna al pubblico.
Se si potesse dare una data ideale al giro di boa che ha costretto chi scrive a portare sulle spalle il peso del dubbio e rappresentare personaggi più reali e al contempo più inquietanti, dovremmo provare a considerare il tempo circolare, liberarci delle gabbie cronologiche e postulare una possibile mescolanza di diacronia e sincronia.
Per il suo potere evocativo e per la larga diffusione della vicenda, poniamo come spartiacque il dubbio amletico. Esso non riguarda solo la possibilità dell’esistenza di una “giusta vendetta”, ma addirittura la totale riscrittura dei rapporti tra vita e morte e tra uomini: così, la bomba deflagra nella narrativa e pone scrittore e lettore di fronte al dubbio grazie all’introspezione o, per dirla più precisamente, alla psicanalisi.
In forza dell’idea di circolarità del tempo delle idee, un archetipo (in questo caso quello del Principe di Danimarca) non deve necessariamente venire cronologicamente dopo un’acquisizione scientifica e, dunque, poco importa l’epoca in cui Shakespeare vi pose mano se Amleto è in effetti roso da inquietudini a cui Freud avrebbe dato, vari secoli dopo, nomi assai precisi.
Ecco il punto: nel momento in cui uno scrittore “giustifica” il male narrando il pregresso di un personaggio gli concede in qualche modo delle circostanze attenuanti e le azioni stesse di un cattivo smettono di essere inchiodate a un pirandelliano teatro di cartapesta, cessano di essere abiti comodi indossati per una commedia dell’arte e diventano il risultato di un portato di traumi. Se sapessimo da Hugo che l’ispettore Javert – ostinato nel suo male e nel cieco desiderio di perseguire Jean Valjean in modo acritico, in forza di un’idea di giustizia che non ammette né espiazione né rieducazione – da bambino era stato vittima di bullismo o di abusi, molto probabilmente saremmo anche pronti a giustificare buona parte delle sue azioni. Stesso discorso può essere valido per qualsiasi personaggio a cui si associa un’idea concreta di male ma, per una curiosa specularità, di rado il pregresso di un personaggio è utilizzato per dare conto delle azioni virtuose di cui si può fregiare.
A questo punto, sia pure con qualche approssimazione, risulta che la narrativa moderna ha dovuto rinunciare alla netta divisione tra buoni e cattivi usando le armi dell’introspezione e della coscienza perché questa è responsabilità precisa dello scrittore: tenere fede al patto col lettore e fornire una narrazione verosimile. Di contro, spogliato di questa stessa responsabilità, l’autore di genere può permettersi di attenersi al realismo descrittivo di fatti e luoghi relegando di contro la vita, la morte e l’amore in uno spazio protetto in cui proprio l’estremo realismo, come in un gioco degli specchi, allontana dal vero per la carenza dello sguardo “dubbioso” sui personaggi.
Forse questo è solo un modo come un altro per esorcizzare la paura della morte e quella dell’amore capace di far compiere azioni estreme. Ma le inquietudini della vita narrate dalla letteratura, sono ben altra cosa.
 Beh, effettivamente in non pochi casi le “muse” di certi scrittori, più che “ninfe dei monti” – come sembra che l’etimologia originaria interpreti il termine – col tempo sono diventate ninfe dei conti! Ma, a parziale rivalsa dell’etica della categoria, bisogna denotare che di scrittori che abbiano conti da fare, nel senso pecuniario del termine e sulla colonna “entrate” del proprio rendiconto, oggi sono ben pochi! Ovvero, in parole povere: non resta che abbuffarsi di lenticchie, visto il periodo, e sperare che almeno questo funzioni…
Beh, effettivamente in non pochi casi le “muse” di certi scrittori, più che “ninfe dei monti” – come sembra che l’etimologia originaria interpreti il termine – col tempo sono diventate ninfe dei conti! Ma, a parziale rivalsa dell’etica della categoria, bisogna denotare che di scrittori che abbiano conti da fare, nel senso pecuniario del termine e sulla colonna “entrate” del proprio rendiconto, oggi sono ben pochi! Ovvero, in parole povere: non resta che abbuffarsi di lenticchie, visto il periodo, e sperare che almeno questo funzioni…

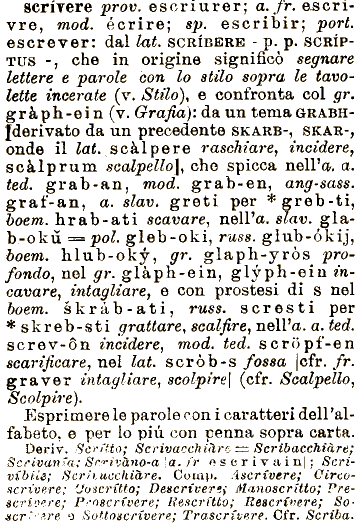

 Cara amica,
Cara amica,
