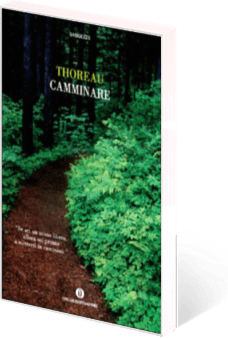Parole fondamentali, dal significato certo e prezioso ma, forse, dalla reale cognizione e comprensione vaga, vacua, fallace se non perduta. Definizioni tratte dal vocabolario Treccani che riproduco qui, per generare una riflessione sul loro senso, sulla nostra conoscenza e consapevolezza di esse, sulla loro presenza nel mondo in cui viviamo e nella nostra esistenza quotidiana.
La parola di oggi è:
 Pace, una parola di quelle assai abusate nell’uso e nel senso, dal valore piuttosto travisato per convenzione sociale la quale le assegna un posto d’onore nell’ambito del (cosiddetto – se mi è consentito dire così) “atteggiamento buonista” dell’opinione pubblica – giustamente e doverosamente peraltro, anche se forse senza tutta la necessaria consapevolezza del caso.
Pace, una parola di quelle assai abusate nell’uso e nel senso, dal valore piuttosto travisato per convenzione sociale la quale le assegna un posto d’onore nell’ambito del (cosiddetto – se mi è consentito dire così) “atteggiamento buonista” dell’opinione pubblica – giustamente e doverosamente peraltro, anche se forse senza tutta la necessaria consapevolezza del caso.
In effetti, a tal proposito, l’etimo della parola rimanda a riflessioni sulla sua accezione originaria piuttosto differenti dal consueto. La radice è la stessa di pattuire, patto: dunque la pace non è una condizione autonoma in sé stessa ma è comunque condizionata ad altri elementi – viene in mente al proposito il celebre motteggio romano si vis pacem, para bellum, il quale sostanzialmente sancisce la pace come il periodo di equilibro non belligerante tra eventi storici viceversa guerreschi, e dunque da questi dipendente. Insomma: la “civiltà” umana, in tutto il suo plurisecolare sviluppo intellettuale, culturale, civico, e quant’altro, non ha saputo fare della “pace” una condizione a sé stante virtuosa e, per così dire, autosufficiente della propria storia, ma l’ha resa momento di pausa tra episodi di conflitto e di guerra. Non situazione di ideale e proficua armonia ma intervallo di calma tra bellicose disarmonie, ecco. L’umanità vive la pace nell’attesa della prossima guerra perché questa, e non la pace, sa fare soprattutto, ahinoi: la storia lo dimostra bene, come parimenti dimostra di non poterci fornire alcun elemento affinché si possa credere che ciò non accada più. D’altro canto i Romani l’avevano capito 20 secoli fa, come già visto, con realismo tanto cinico quanto del tutto tangibile ancora oggi.
In fondo, anche lo stare in pace con sé stessi – ulteriore accezione in uso della parola – è per molti versi uno scendere a patti con, appunto, sé stessi. Fino a che qualcosa interviene nella vita e rompe quel patto, quell’equilibrio – dacché, io credo, nessuno comunque spererà di ritrovarsi in una condizione di pace eterna, visto il senso di tale espressione la quale, tuttavia, è forse la sola che segnala drammaticamente l’unica “pace” che non possa più essere rotta da qualcosa o qualcuno. E per nostra colpa – di “civiltà” umana, intendo (virgolette indispensabili, qui e prima!) – non certo, almeno nel principio, per malaugurata sorte o che altro.