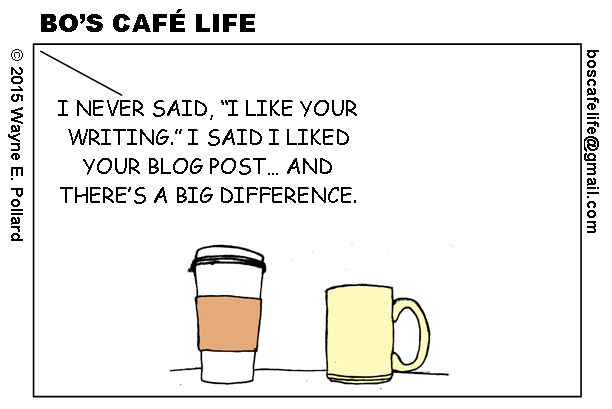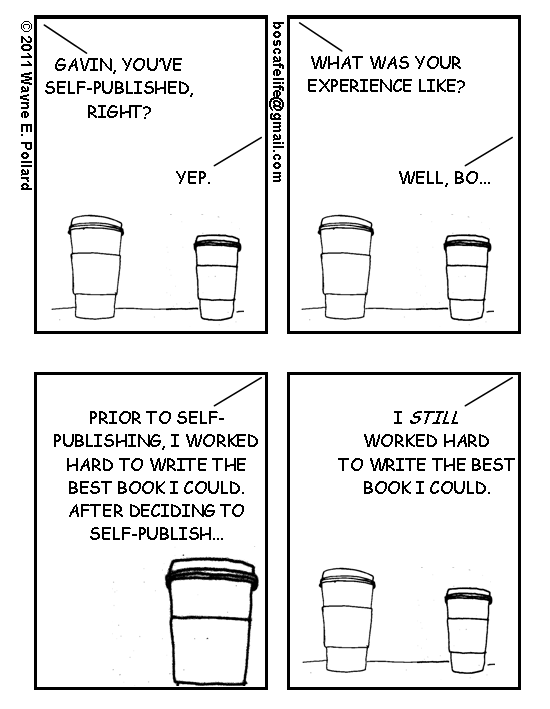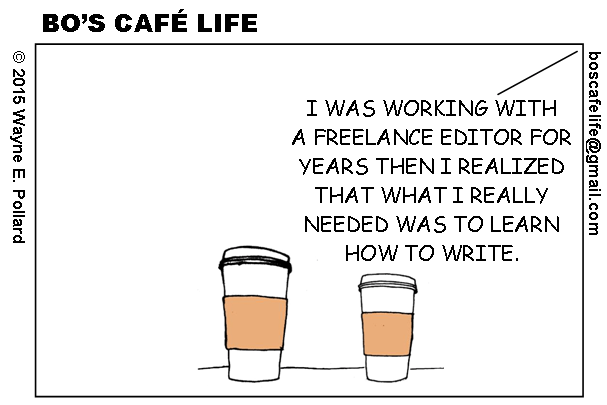Be’, e se si cominciasse col mettere in discussione la cittadinanza italiana di tutti quegli “italiani” che dimostrano palesemente di non saper scrivere correttamente nella propria lingua, ovvero di non saper padroneggiare uno degli strumenti culturalmente fondamentali per potersi dire parte della comunità sociale nazionale, per giunta pure uno di quelli più significativi al fine di comprendere il bagaglio culturale in possesso (ovvero, dall’altro verso, la gravità delle relative mancanze) del soggetto in questione?
Be’, e se si cominciasse col mettere in discussione la cittadinanza italiana di tutti quegli “italiani” che dimostrano palesemente di non saper scrivere correttamente nella propria lingua, ovvero di non saper padroneggiare uno degli strumenti culturalmente fondamentali per potersi dire parte della comunità sociale nazionale, per giunta pure uno di quelli più significativi al fine di comprendere il bagaglio culturale in possesso (ovvero, dall’altro verso, la gravità delle relative mancanze) del soggetto in questione?
Suvvia, non siamo più ai primi del Novecento, quando l’ancora scarsa alfabetizzazione della popolazione italiana non poteva essere correlabile né alla sua ignoranza culturale, né viceversa alla frequente intelligenza e saggezza che a quei tempi la vita anche più della scuola poteva insegnare! Siamo nel 21° secolo, anno 2018 (duemiladiciotto!), in piena era dell’informazione, con qualsiasi conoscenza culturale (lessicologica e non) a portata di tutti: la svista ci sta, l’errore di battitura causale e il sovrappensiero del momento pure, ma certe castronerie linguistiche che si leggono diffusamente sui social semplicemente non sono ammissibili dacché, ribadisco, risultano un segno inequivocabile di grave superficialità culturale oltre che di dissonanza cognitiva, di analfabetismo linguistico-funzionale, di “svacco” identitario (ma potrei dire di ignoranza, per farla breve), al punto da suscitare gravi dubbi sulla conformità di tali individui rispetto ai valori culturali storici del paese – scrigno di cultura senza pari, al mondo, è bene ricordarlo. “Italiani” che scrivono in italiano come fossero bambini di seconda elementare, ma con un maggior numero di errori di ortografia e grammatica: ditemi pure che sono cinico, sprezzante, arrogante o che altro, ma io costoro, prima di un adeguato e rigido periodo di rialfabetizzazione, non posso affatto metterli sullo stesso piano di altri italiani che invece dimostrano di possedere tali nozioni basilari.
E, per essere chiari, non è una questione di idee espresse da quelli o questi, ci mancherebbe. Anzi, semmai proprio l’opposto: che l’incapacità espressivo-linguistica di certi individui è garanzia certa di inabilità intellettuale. Di un cervello in consunzione, già, senza che il relativo proprietario faccia il minimissimo sforzo che in tal caso occorre per riattivarlo: per pensare a ciò che si scrivere e per scriverlo in modo da identificarsi come italiano, non come un forestiero che conosca la lingua nazionale da solo poco tempo. Forestieri che in molti casi, almeno da questo punto di vista linguistico, la cittadinanza italiana la meriterebbero più di molti “italiani”.
P.S.: peraltro, per singolare coincidenza, proprio in questi giorni (e dopo che ho scritto questo articolo), un comune della bergamasca ha pensato bene di istituire un corso di italiano per italiani. Ecco, appunto.