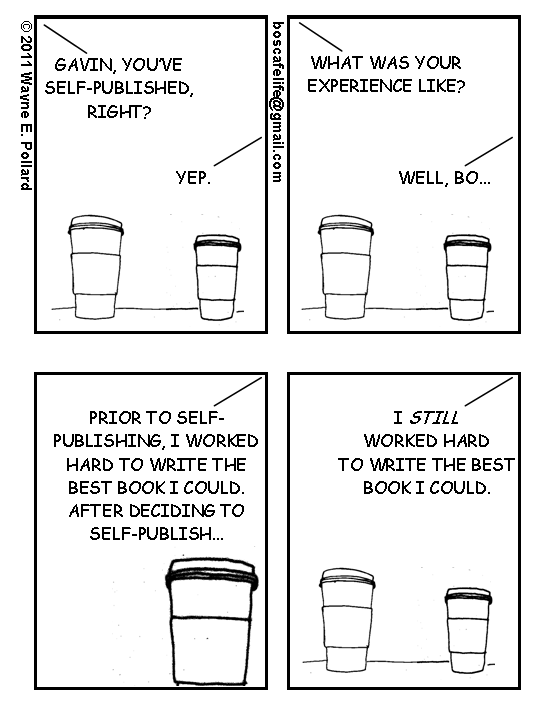David Foster Wallace. Giù il cappello, senza dubbio alcuno e anche per chi non lo ho conosce o non è mai riuscito ad apprezzarlo.
Infinite Jest: un capolavoro assoluto per alcuni, un mattone inesorabile per altri, uno dei tanti libri da leggere presto per altri ancora tra cui lo scrivente, che Wallace lo ha già conosciuto e apprezzato con altre letture.
Ma un libro come Infinite Jest – ovvero molte altre opere che hanno saputo conseguire lo status di cult book e dunque andare oltre la loro mera dimensione letteraria/editoriale, anche al di là del nome più o meno altisonante che le firma – può certamente essere affrontato, esplorato, analizzato, letto (nel senso più ampio possibile del termine) anche in altri modi. Molto interessanti e intriganti, anche per l’atteggiamento artistico che li contraddistingue, sono quelli messi in atto dalle nordamericane, Corrie Baldauf, artista americana, e Barbara Balfour, scrittrice canadese.
Ciò che hanno fatto con il celebre romanzo di Wallace è narrato in questo bell’articolo uscito su Artribune Magazine #24 a firma di Sara Boggio, che vi riproduco di seguito anche per come può certamente essere ispirante altre simili pratiche di lettura indiretta o mediata di un’opera particolarmente adatta allo scopo – e beh, inutile dirlo, non tutti i libri lo sono, adatti, vista certa imperante pochezza letteraria, narrativa, stilistica e quant’altro oggi viene assurdamente pubblicata da tanti editori… ma questo è un altro discorso.
 David Foster Wallace. Un ricordo a colori
David Foster Wallace. Un ricordo a colori
di Sara Boggio
Cimentarsi con uno dei capolavori più ostici del XX secolo non è semplice, per definizione. E così in molti si sono arenati fra le pagine di “Infinite Jest”. Ma una volta entrati in gioco, allora la dipendenza è assicurata. E può trasformarsi, ad esempio, in un profluvio di post-it…
REPORTAGE ANTROPOLOGICI
“Ho visto completi fucsia e giacche rosa mestruo e scaldamuscoli viola e marroni e mocassini bianchi senza calzini”, scriveva David Foster Wallace (Ithaca, 1962 – Claremont, 2008) a proposito di una crociera extra-lusso nei mari caraibici, in mezzo a “intensità di blu oltre il blu più limpido che si possa immaginare”, e in compagnia della specie di turisti più viziata e peggio vestita d’Occidente. Una cosa divertente che non farò mai più è una cronaca di viaggio impietosa ed esilarante, come tutti i suoi servizi da inviato speciale. Che sono veri e propri reportage antropologici. Ma anche fotografie, ad altissima definizione, di persone e cose, sotto cieli che variano dal “color acciaio a basso tenore di carbonio” al “colore di un paio di jeans usati”, tra facce “color bistecca al sangue” o dall’“abbronzatura terrigna”. Il database di tinte che colora la scrittura di Wallace, e che nei romanzi si apre a uno spettro cromatico ancora più esteso (e potente), è il corrispettivo di una tavolozza: impressionista, espressionista e/o surrealista, usata con la padronanza tecnica di un fiammingo e lo sguardo affilato di un iper-realista.
INFINITE JEST: UNA CULT-NOVEL
Eppure Wallace, come quei due o tre pilastri a secolo che riescono a incidere sull’impalcatura culturale del tempo proprio e a venire, e che non cavalcano l’onda dell’accessibilità immediata, intimidisce. Intimidisce anche la sua scomparsa, che si dice prematura o tragica pur di non citare il suicidio con il suo velo di stigma. E quindi capita che sullo statuto di genio attribuito all’autore e di capolavoro al suo lascito siano tutti d’accordo, ma per sentito dire: Infinite Jest, in questo senso, è forse il libro di culto più citato di fine millennio e il meno letto.
Un omaggio (inatteso, vista la cornice) è stato reso a Wallace l’anno scorso dalla Biennale del Whitney di New York. Presi in prestito dal Ransom Center dell’Università di Austin, Texas (che ne conserva tutto l’archivio), e sistemati in un paio di teche del quarto piano, erano esposti dei manoscritti: una serie di note per l’intervista a Federer (apparsa sul New York Times nel 2006) e diverse pagine dell’ultimo romanzo, Il Re Pallido, incompiuto e pubblicato postumo, nel 2011. Fogli di brutta. Dall’aspetto particolarmente sobrio dopo centinaia di metri quadri di stimoli visivi e sonori da biennale, ma del tutto appropriati all’occasione, se il punto del Whitney è valutare lo stato dell’arte in America (e magari mostrarlo in buona salute).
UNA LETTURA CROMATICA
Del resto, tornando al lessico cromatico di Wallace e pensando a quanto è colorata la sua prosa, i suoi libri si addicono alla perfezione alle arti visive. A partire proprio dall’opera che esercita la più severa selezione all’ingresso: Infinite Jest. Non è un caso che ad accorgersene siano state due artiste: Corrie Baldauf, americana di base a Detroit, e Barbara Balfour, canadese di base a Toronto. Casuale, invece, la folgorazione di entrambe per i colori di Infinite Jest (nonché l’assonanza linguistica tra i cognomi).
Baldauf non era una devota di Wallace, e per affrontare le oltre 1.200 pagine del libro si è inventata un escamotage: concentrare l’attenzione sulle parole che indicano i colori e segnalarle con un post-it dalla tinta corrispondente (Infinite Jest Project: Phase 1, 2014). L’espediente ha funzionato anche oltre il previsto. Conclusa la prima lettura, ha subito ricominciato da capo, questa volta per fare una mappatura tematica e cronologica (Only Only: Phase 2 of the Infinite Jest Project, 2014). Nel frattempo ha iniziato a postare su Twitter le sue annotazioni, trasformando il raccoglimento della lettura in un dialogo che ha chiamato a raccolta migliaia di lettori di Wallace. Pura polifonia post-moderna. Per l’artista, un’esperienza di profonda “intimità digitale”, che non si sarebbe mai aspettata dalla comunicazione a 144 caratteri del social. E ora Baldauf è al terzo atto, per fare il tracciato dei nomi.
UN LIBRO CHE DÀ DIPENDENZA
Barbara Balfour, prima di immergersi nella lettura, ha dovuto superare un momento di rifiuto dovuto allo status di culto da cui il libro era circondato quando è uscito. Poi è semplicemente arrivato il momento giusto, e siccome le parole di Wallace impongono continui arresti al flusso narrativo, lei iniziato ad annotarle e ne ha concepito, a sua volta, un libro (The Inkiest Black, 2014), dove sono riportati elenchi di vocaboli (Long List) e di colori (Qualified Colors, White, Black). E dunque, oltre a innamorarsene, che cosa ci fa un’artista visiva con un “rosa osceno”, un “verde indeciso”, un “arancione da disfacimento autunnale”, con il “rosso polveroso del fuoco attraverso il fumo” o con il “colore sottilmente triste del primo pomeriggio invernale”? Li traduce in pigmenti, ovviamente. Così ha fatto Balfour con le sue strisce di colore steso a spatola, come nei campionari per tintometro.
Però nemmeno lei è sicura di aver chiuso i conti con Infinite Jest. Una forma di dipendenza, suprema ironia del titolo, misteriosa alchimia tra parole e colori? È evidente che per capire non basta leggere: bisogna vedere le parole. E allora “sarà come passare dal bianco e nero al colore”, direbbe giustamente il Re Pallido.
 Ah, le donne, capaci di portare gli uomini alla perdizione! Beh, ovvio che non è proprio così, in verità, perché il “merito” di quella perdizione va semmai ricercato nell’ingenuità e nell’ottusità di molti uomini (che ormai “sesso forte” non lo sono più da decenni – e meno male, per certi aspetti). Anzi: e se quella “perdizione” da qualcuno paventata e messa a colpa delle donne non sia invece una visione perbenista se non oscurantista di un buon concetto di libertà, che altrimenti tanti uomini non saprebbero ottenere? Tanto più se si è di sesso maschile e di religione ebrea ortodossa…
Ah, le donne, capaci di portare gli uomini alla perdizione! Beh, ovvio che non è proprio così, in verità, perché il “merito” di quella perdizione va semmai ricercato nell’ingenuità e nell’ottusità di molti uomini (che ormai “sesso forte” non lo sono più da decenni – e meno male, per certi aspetti). Anzi: e se quella “perdizione” da qualcuno paventata e messa a colpa delle donne non sia invece una visione perbenista se non oscurantista di un buon concetto di libertà, che altrimenti tanti uomini non saprebbero ottenere? Tanto più se si è di sesso maschile e di religione ebrea ortodossa… Leggete la recensione completa di Non tutte le sciagure vengono dal cielo cliccando sulla copertina del libro lì sopra, oppure visitate la pagina del blog dedicata alle recensioni librarie. Buona lettura!
Leggete la recensione completa di Non tutte le sciagure vengono dal cielo cliccando sulla copertina del libro lì sopra, oppure visitate la pagina del blog dedicata alle recensioni librarie. Buona lettura!